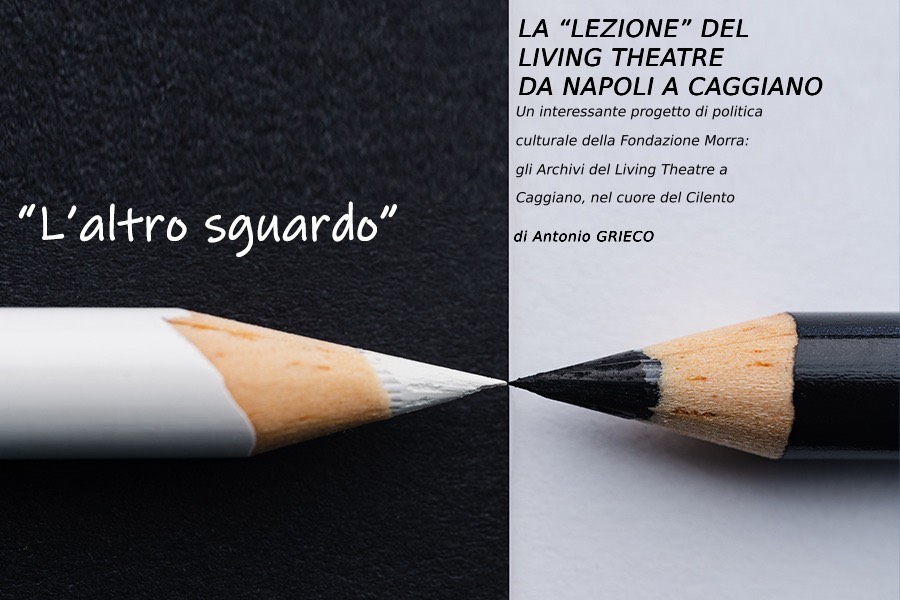A proposito di poetica teatrale
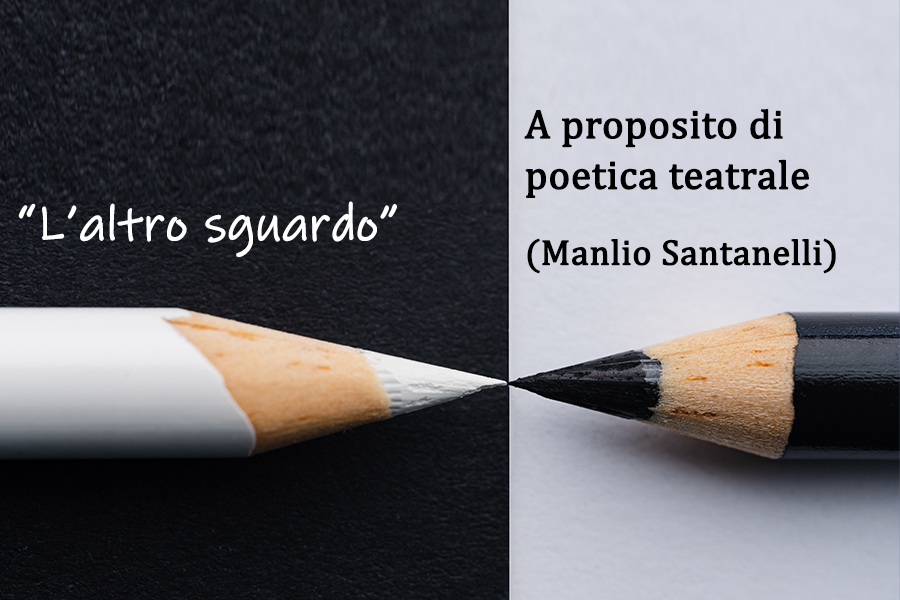
L’ALTRO SGUARDO
A PROPOSITO DI POETICA TEATRALE
(di Manlio Santanelli)
Mi sia concessa una breve immersione ‘in apnea’ nel mio passato; un passato che non è in distonia con il contesto di questa rivista, e in via del tutto personale ha costituito un momento fondante nella mia formazione culturale, indicandomi un binario lungo il quale articolare la mia personalità di autore e, di conseguenza, la mia scrittura.
In un pomeriggio ormai lontano ero seduto nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, e pendevo dalle labbra di Pier Paolo Pasolini che per l’occasione, davanti ad uno scelto pubblico, rifletteva su uno dei nodi primari della letteratura. La sua riflessione ruotava attorno ad una distinzione di fondo tra letteratura consolatoria e letteratura problematica, Secondo l’illustre relatore, la prima si diletta ad aprire soltanto i problemi che già sa di potere in qualche modo chiudere; la seconda si fa carico di aprire proprio quei problemi di cui non possiede la soluzione.
Ciò premesso, e premesso ancora che io non credo nell’esistenza di una poetica unica, che sottenda l’opera di uno scrittore, bensì in tante poetiche quante sono le opere dello stesso, accetto comunque la sfida di confrontarmi con detto tema.
Tema che nella sua ampiezza e complessità richiede un non trascurabile sforzo di concisione, giacché la poetica di un drammaturgo, a mio avviso, va ad affondare le sue radici in quella interiorità da cui prendono le mosse i principali stimoli della vita. Parafrasando un postulato filosofico che ha avuto più versioni nel tempo, sono tentato di dire: “scrivo, ergo sono”. In tal modo accade che quella poetica di cui sopra diventa la guida nell’espressione di una necessità vitale. Quando mi accingo a scrivere (di teatro) non obbedisco ad una pulsione gioiosa, non lo faccio in uno stato di grazia. Al contrario, devo dare sfogo ad una necessità vitale, fisiologica sarei tentato di dire. Non ricordo un solo caso in cui mi sono seduto al tavolo di lavoro con la gioia di vivere. In simili circostanze ho sempre registrato una sorta di ansia, di paura di non essere in grado di riempire dignitosamente la pagina bianca che mi stava avanti. Il postulato “scrivo, dunque sono” (appostato in chissà quale recesso della mia personalità) mi teneva e mi tiene tuttora in una condizione di incertezza, l’incertezza che spesso proviamo nell’iniziare un viaggio. Perché la scrittura, e di conseguenza la sua poetica, è un vero e proprio viaggio, molte volte senza una precisa destinazione. E qui prende corpo la mia fisionomia di scrittore. A differenza di coloro, che maturano dentro di sé la propria idea drammaturgica, e poi passano a svilupparla dandosi una “scaletta”, io credo in una sorta di scrittura che si fa tale nel momento in cui viene alla luce; una scrittura nella quale le parole hanno il misterioso potere di autogenerarsi.
Con questo non arrivo a sostenere che chi scrive deve rispondere ad una sorta di demone platonico, al quale non ci si può sottrarre. Lo scrittore rimane comunque alla guida della sua scrittura; ma, laddove un’espressione gli schiude un nuovo orizzonte narrativo non ci pensa due volte e le va dietro, in obbedienza alla già detta fiducia nella capacità autocreativa della parola. Non diversamente da un provetto viaggiatore che, incontrata nella sua guida la formula “merita una deviazione”, lascia temporaneamente il percorso che stava seguendo, per andare dietro questa nuova prospettiva che gli offre la scrittura stessa. Tale metodo gli permette di non perdere nessuna delle occasioni che incontra nel suo viaggio grafico, e comunque non gli nega la possibilità di ritornare sul percorso primario. Un siffatto tipo di poetica presenta la vantaggiosa capacità di autosorprendersi, condizione primaria per poter sorprendere prima l’attore che interpreta quel passo, poi il pubblico che ne è l’ultimo destinatario. In poche parole, se è mia intenzione sorprendere il pubblico, devo prima sorprendere me stesso. Da qui al concetto seguente il passo è breve. Senza timore di apparire spudorato, confesso che io scrivo esclusivamente quello che vorrei vedere sulla scena. Durante il processo creativo, dunque, mi faccio automaticamente spettatore di me stesso, scrivo ciò che mi piacerebbe andare a vedere messo in scena quella sera.
A questo punto ritengo di essermi dilungato quanto so fare sull’argomento in analisi. Per amore di sintesi, mi permetto di fare ricorso ad un passo di “Regina Madre”, l’unico testo in cui affronto di petto il mio punto di vista sulla poetica teatrale. Si tratta della “tirata” in cui Alfredo, giornalista deluso, tenta di spiegare il suo malessere (che ormai da professionale è diventato esistenziale) alla vecchia matriarca.
ALFREDO: … E allora mi sono gettato nel lavoro. Peggio che mai.!… Perché quella mancanza di chiarezza che mi portavo nel fondo me la sono trovata pari pari in quello che facevo… in quello che scrivevo… Ma che ti sto a raccontare…E’ un problema mio, troppo mio!… Lo so io il disgusto, il malessere che può arrivare fino al rigetto, al vomito mentale per quello che un attimo prima mi pareva vero, sincero, degno di essere espresso, e in grado di resistere a quel temporale che si scatena sulle parole nel tragitto dal mondo delle cose dette a quello delle cose scritte. La so io la miseria, la dannazione… Sì, tutti questi anni io ho vissuto traghettando parole da una riva all’altra, parole che alla partenza prendo sempre per buone, e all’arrivo mi accorgo che sono marce, e che devo buttarle… Hai presente un fiume?… Ecco, ecco la mia vita. E allora diciamo che la dannazione è questa: da una parte del fiume c’è il pensiero, con le sue fantasie, belle o brutte che siano… con i suoi voli, ali o bassi non importa. E dall’altra una pagina, bianca, schifosamente bianca, che devo riempire per forza, perché tutto quel bianco non lo sopporto, mi manda in bestia, o meglio mi risucchia, mi attira come un abisso insondabile! E allora vado su e giù da una riva all’altra… badando di tenere alte quelle parole, ben alte sul capo per evitare che durante la traghettata si inzuppino di significati che non ho voluto… Ma forse è questo il mio errore, forse il rischio dovrei accettarlo tutto… quel bagno dovrei persino procurarlo… E perché non lo faccio? Perché ho paura. Sì, sì, ho paura! Perché alcune parole, altro che renderti miope, quelle sì che possono accecarti! E allora … Ma io faccio solo chiacchiere… mi perdo… Ecco, mi sono perduto. Dove eravamo rimasti?
Manlio Santanelli