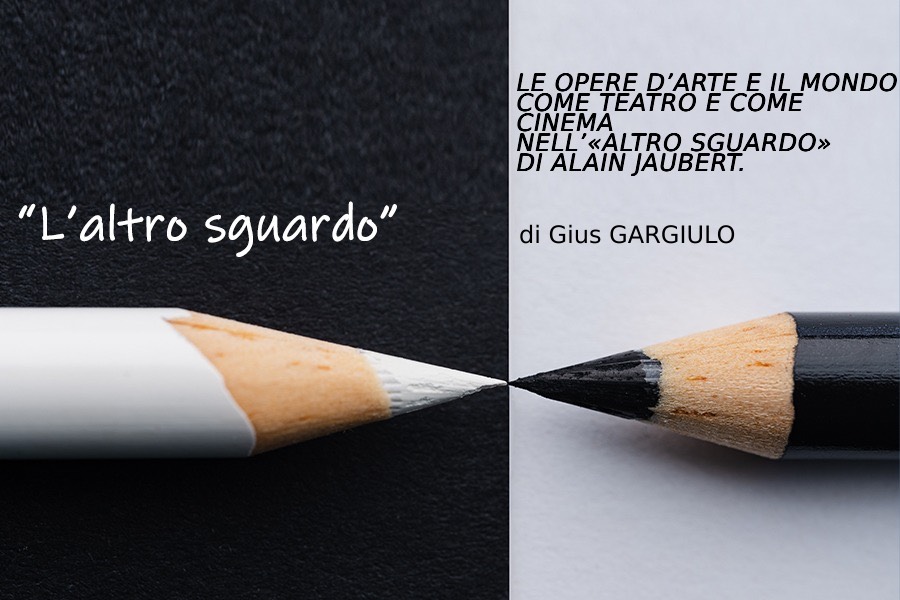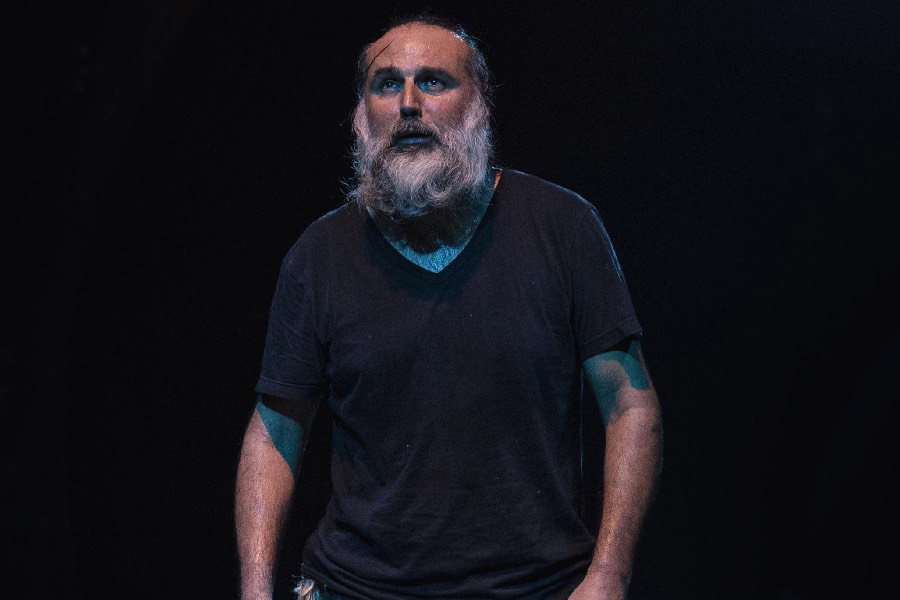Guida Galattica per i Lettori | Luglio 2023

contenuti
- AMICO ROMANZO La donna che visse nelle città di mare di Annalisa ARUTA STAMPACCHIA
- SIPARI APERTI Teatro Cargo di Emanuela QUARANTA
- COME SUGHERI SULL’ACQUA Posso ancora disegnare barche sui muri della mia casa di Ariele D’AMBROSIO
AMICO ROMANZO
LA DONNA CHE VISSE NELLE CITTA’ DI MARE
di Annalisa ARUTA STAMPACCHIA

Marosella Di Francia e Daniela Mastrocinque le abbiamo incontrate al Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale e Europeo dove è stato presentato il loro romanzo-divertissement Amiche di penna, Il romanzo epistolare di Anna Karenina e Emma Bovary. Qui le vicende immortali e paradigmatiche di Anna e Emma, protagoniste esemplari di una tipologia umana e di un’epoca storica, escono dalle pagine scritte da due giganti della letteratura mondiale, Tolstoi e Flaubert, per incarnarsi e vivere in altre vicende, frutto della scintillante fantasia e dello straniamento delle due autrici che, infiltrandosi nella loro vita, ne esplorano l’inesauribile vitalità per suggerire altre vite possibili.
Ne La donna che visse nelle città di mare Di Francia e Mastrocinque continuano il loro consolidato sodalizio e ritornano per riprendere a narrare, secondo i loro canoni di scrittura, le vicende della vita di Giuseppina di Tarro, un’ava di Marosella, che spesso ricorreva nelle ‘storie’ che si raccontavano in famiglia. Sono state necessarie molte ricerche storiche e di archivio sull’ambiente e l’epoca in cui aveva vissuto Giuseppina per orientare le scrittrici nella stesura del romanzo. Nasce la figura di Costanza Andaloro, la protagonista che, nel 1904, vive nella Palazzata affacciata sul mare di Messina. La giovane donna si prepara a vivere la bella stagione della sua giovinezza e la gioia della festa per il suo fidanzamento con Alfonso. Da una parte sapere come sarebbe stata la sua vita la rassicurava, ma aveva anche altri interrogativi per la testa e si chiedeva se fosse «possibile anche per una donna di buona famiglia fare qualcosa che le piacesse che non fosse solo l’accudimento di una casa, di un marito e dei figli» (p. 21). Intanto il destino aveva già deciso per lei. La festa tanto attesa, sognata non avviene: il padre, stimato medico, misteriosamente si uccide. Da questo punto in poi il romanzo prende dimensioni e direzioni diverse e Costanza andrà verso una svolta fondamentale della sua vita: soprattutto forgerà carattere, desideri, prospettive secondo i lati più nascosti e, forse, a lei stessa ancora ignoti della sua anima. Questa transizione è scelta dalle due scrittrici per dare spessore al personaggio che, vivendo l’avventura di un’esistenza diversa, si indirizza verso scelte per lei inattese, imprevedibili, ma al tempo stesso formative per attraversare cammini difficili, ma sicuramente più veri di quelli già segnati nella sua vita siciliana. La svolta si chiama New York e il mare, dove procede il piroscafo, è al tempo stesso elemento noto che Costanza ha sempre avuto sotto gli occhi, mentre dalla sua bella Palazzata si affacciava su quella immensità, ma ora il mare la porta, con il ritmo delle navi di inizio secolo, verso un paese nuovo. Così quel mare – dice Verga- che «non ha paese nemmeno lui» diventa via nota e possesso «di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce il sole». Costanza giunge in America paese sconosciuto, per la via più familiare per lei , nata e vissuta a Messina, città di mare. Fin dai primi giorni New York l’afferra e la stordisce e subito si rende conto che « quella città palpita di vita come se ci fosse un ingranaggio sotterraneo che la manovra» (p. 131). La statua della Libertà, in mezzo al mare, la stupisce e le sembra una Madonna laica collocata « per accogliere quanti arrivando da mondi lontani, speravano in una nuova vita» (p. 131), così come la sperava lei appena approdata in America.
Costanza a New York riprende a scrivere il diario, consuetudine che le serve per riannodare il legame con la sua famiglia e col mondo che ha lasciato. Il diario e le lettere che riceve da casa, sul piano della scrittura, sono due strumenti che permettono all’azione del racconto di procedere tra passato e presente. Costanza conosce Frank e mentre la sua vita sembra prendere un’angolatura diversa, ancora una volta una grande tragedia, il terremoto di Messina, la travolge inghiottendo tutta la sua famiglia. La sua bella casa è ridotta a un cumulo di macerie e il posto dove aveva sognato di tornare un giorno, non esiste più. Un torpore la avvolge, la paralizza, chiusa in se stessa come in un bozzolo riesce solamente a respingere tutti «come fossero insetti fastidiosi da cui difendersi» (p. 209). Così, in preda a un profondo senso di colpa, anche Frank e i suoi progetti di futuro insieme sono respinti. Improvvisa la decisione di sposare il maestro di musica Pietro Malara che viveva a New York e già da tempo la corteggiava: è il suo modo per cercare di placare l’angoscia e riempire il vuoto che sente dentro di sé. Quando Pietro deve recarsi a Napoli, per una questione ereditaria, decide di seguirlo. Ancora una volta torna a vivere in una città di mare dove il nuovo fermento economico di inizio secolo, la cattura, le darà nuova forza spingendola a cercare un lavoro per essere indipendente e più libera.
Napoli e le vicende vissute da Costanza in questa città riempiono la terza parte del libro dove l’’inventio’ della narrazione degli anni napoletani è affidata a Lucilla, nipote di Rosa, nata da Costanza e da Pietro. Lucilla, una cantante lirica, convocata per un’audizione al San Carlo di Napoli, trova per caso una lettera da Napoli, ancora chiusa, di Costanza a Rosa. Dopo averla aperta incomincia a porsi domande su questa bisnonna che non ha conosciuto e si propone di indagare, durante il soggiorno napoletano, sul contenuto, alquanto misterioso, di quella lettera. Costanza ha abitato a Napoli al Supportico Lopez, nel rione Sanità. La Sanità, come è comunemente indicato la zona, è un quartiere a parte nella topografia napoletana, lontano e diverso dalla solita cartolina partenopea, il mare e il Vesuvio sono sullo sfondo, ma non la connotano: è un presepe di case e stradine che da Capodimonte scende a valle, racchiudendo una sua realtà fatta di miti, riti e liturgie che preannunciano, sono un apprendistato alle cerimonie legate al Cimitero delle Fontanelle dove si coltiva il culto delle anime ‘pezzentelle’, le anime abbandonate di morti che sono in Purgatorio e in cambio di preghiere promettono protezione ai vivi che pregano per loro. La scelta di Di Francia e Mastrocinque di far ricercare a Lucilla, proprio nel quartiere della Sanità, le tracce di Costanza non è casuale. Napoli, legata ai misteri eleusini che celebrano lo stretto rapporto tra la vita e la morte, « è una città con due anime, è il regno dei vivi e dei morti, è il luogo del sole, ma anche del buio» (p. 325). Alla Sanità, spazio arruffato e labirintico di vicoli bui, meglio si esprime il collegamento con il mondo dei morti: perciò la resurrezione del passato di Costanza trova in quell’area urbana lo scenario migliore dove Lucilla possa incontrare l’anima e il passato della sua bisnonna. Cercando e domandando nel quartiere dove sia il Supportico Lopez la giovane cantante arriva finalmente a scovarlo. Vi abita Zina, una vecchia signora, parente di Costanza, cugina di sua nonna Rosa che, superati i primi momenti di diffidenza, le apre la casa e sul filo della memoria comincia a raccontare.
Ai ricordi di Zina le scrittrici aggiungono ancora, come strumento narrativo per fare luce sulla vita napoletana di Costanza, il suo diario che Lucilla trova nella stanza dove la vecchia signora la ospita.
Veniamo a conoscenza che Costanza fin dal suo arrivo a Napoli ama uscire e vedere il più possibile questa città che sollecita il suo sguardo, la sua curiosità. Con Pietro alloggia in un lussuoso albergo del lungomare e il marito la riempie di attenzioni e preziosi regali conquistandone finalmente l’amore. Purtroppo l’eredità che è stato il motivo del viaggio in Italia, è invece una grande delusione: per lui solo un palazzo fatiscente che stenterà a vendere e la sua speranza di raccogliere fondi per finanziare la banda musicale che voleva organizzare al suo ritorno in America, si rivelerà un sogno impossibile. Mentre Pietro diventa sempre più critico e distaccato dalla realtà napoletana, Costanza sente una nuova energia e le sembra come di riemergere in superficie «tutto a un tratto dopo aver vissuto sott’acqua per tanto tempo» (306). Ora che la situazione economica del marito non è più florida come avevano sperato, contando sull’eredità, Pietro deve accontentarsi di qualche lavoro che non ama, magari anche saltuario. La coppia, lasciato l’albergo, va ad abitare al Supportico Lopez alla Sanità dove la cura del bel giardino della casa appassiona Costanza che riprende anche a disegnare. Costanza aveva sempre avuto la passione per il disegno, in particolare amava disegnare figurini di moda. A New York per Luigi e Anna della sartoria Squillace, sue vecchie conoscenze messinesi, aveva cominciato a disegnare, quasi per gioco, figurini che poi erano diventati invece un impegno, un lavoro. Per aiutare Pietro decide di cercare lavoro a Napoli e, attirata dalla pubblicità dei Magazzini Mele chiede se c’è un lavoro per lei e a poco a poco si afferma nell’occupazione che ha trovato solo per aiutare suo marito. Il lavoro comincia a piacerle e progredendo arriva a inserirsi nel ramo che più la appassiona, la modifica sartoriale degli abiti, calibrata sulla figura delle acquirenti dei Magazzini Mele. Diventerà cosi brava che la moglie di un dirigente del teatro San Carlo, sua abituale cliente, le chiede di diventare aiuto costumista al San Carlo. Il lavoro e le soddisfazioni che ne trae le danno la forza di superare quel dolore infinito che il terremoto di Messina le aveva procurato con la perdita di tutto, famiglia, affetti, casa. Pietro sempre più triste, deluso, amareggiato dal non vedere riconosciuto il suo talento di musicista, pur amandola decide di tornare in America. Per Costanza, Napoli, quella casa alla Sanità e, soprattutto, un lavoro che le piace hanno guarito le sue ferite, perciò non partirà. Rimarrà per sempre in quella città dove l’allegria è solo apparente perché – dice Concetta, la sua cameriera , donna sensibile e di cuore- «Napoli è tutto ‘nu dolore’. Il dolore, chi vive qua, lo annusa, poiché lo conosce da sempre». Lei che quel dolore lo ha attraversato, preferisce rimanere dove ha ritrovato la sua anima e anche dopo la scoperta di essere incinta e la nascita della figlia Rosa, rimarrà a Napoli. Pietro, nonostante le ripetute promesse di tornare, continuerà à vivere in America. Unico segno, in dono per la piccola Rosa in occasione della sua nascita, invia una sua composizione e poi nulla più.
Marosella Di Francia e Daniela Mastrocinque in La donna che visse nelle città di mare hanno proposto come protagonista del romanzo Costanza, una donna forte, non priva di contraddizioni che, alla ricerca di se stessa, vive, ma non subisce le incoerenze e i contrasti dei colpi del destino e sulla scena dei tempi che cambiano, afferma la sua determinazione a costruirsi differente dai modelli femminili che la società dell’epoca prospettava. e, solo apparentemente, tutelava.
SIPARI APERTI
TEATRO CARGO
di Emanuela QUARANTA

Dedicato a Genova e Catania, il volume di Laura Sicignano ripercorre le tappe di questa nave-teatro che è CARGO, dei suoi oltre vent’anni di viaggio, delle sue rotte, in tacita obbedienza a quel “pendolarismo malinconico e faticoso che accomuna una generazione di genovesi in fuga” (p. 10) seguendo itinerari antichi, custoditi nei solchi della memoria, eppure sempre nuovi, coniugando tradizione ed innovazione.
E se non avevano torto gli antichi nel recitare che nomina sunt omina, dando voce alla credenza secondo la quale nel nome delle cose sia impressa un’ombra che ne suggerisce il destino e le virtù, come un presagio, in obbedienza, forse, a questa suggestione, nel caso del Teatro CARGO – fondato da Laura Sicignano nel 1994, con le socie Laura Benzi, Maria Grazia Bisio e Paola Ratto – “ci voleva un nome forte” (p. 7), scrive la regista. Questo nome fu CARGO: “una nave mercantile sempre in viaggio. Un contenitore per idee che parte verso mete lontane, carica, scarica e riprende il viaggio. Solido, compatto, ma vuoto per essere colmato di qualsiasi cosa, di qualsiasi idea. Bello anche, di una bellezza contemporanea, quando lo vedi all’orizzonte del mare di Genova”. (p. 7)
Il primo capitolo del volume, dal titolo “Le origini”, ripercorre la nascita e gli esordi di un teatro nato nel 1994, quando “un gruppo di ragazze appassionate di teatro – e fuori di testa” scrive Laura Sicignano “si riuniscono al settimo piano, senza ascensore, di una casa nei vicoli di Genova: la mia” (p. 7), ricordando i primi spettacoli, finanziati con oggetti recuperati, reinventati e venduti, “secondo una filosofia del riuso poi divenuta moda” (p. 7). Le inserzioni biografiche, inoltre, offrono uno spaccato di una generazione, quella dei giovani dei “tristi Anni Ottanta”, “consapevoli di non valere quanto le mitiche generazioni precedenti” (p. 9) e delle riflessioni e degli interrogativi di questa generazione sul senso del fare teatro.
Il racconto della produzione di CARGO segue una direttrice cronologica. Nel 1995 l’esordio fu AMERICAN PSYCHO, tratto dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, uno spettacolo che inaugurò una prassi poi ricorrente nella produzione del CARGO: la trasposizione teatrale di opere letterarie che proseguirà con spettacoli quali IL MAESTRO E MARGHERITA, UN ANGELO VIENE A BABILONIA e SALOMÈ, definite da Laura Sicignano “favole visionarie” che analizzano i rapporti di potere (o, meglio, del Potere!) con cui devono districarsi, spesso, i giovani e gli artisti.
Un momento di svolta – come racconta la regista – avvenne in seno al cosiddetto “Progetto giovani”, bando del Ministero dei Beni e le Attività Culturali per finanziare nuove formazioni teatrali: iniziò così la collaborazione con lo Stato e gli Enti locali. CARGO vinse il bando con un progetto senza “tutor”, quasi per errore, sostiene Laura Sicignano (o per destino?), profilandosi come un teatro senza “né padri, né padroni, né padrini” (p. 17), self-made, secondo una cifra che gli sarà poi distintiva.
L’anno 1999 inaugurò il ciclo degli “eroi perdenti”: vennero rappresentati spettacoli come LE ZIE – opera en travesti, ritratto amaramente ironico del Settecento prerivoluzionario, dilaniato “tra la ragione e i suoi mostri” (p. 18) – e IL FUNAMBOLO, tratto da un’opera non teatrale di Genet, rielaborazione della storia vera tra l’autore e il giovane Abdallah. Nel 2002 CARGO ottenne la gestione del Teatro del Ponente, uno spazio “neutro e senz’anima”, “pieno di difetti”, “lontanissimo dal centro!” (p. 23), a Voltri. Eppure, facendo di necessità virtù, il vuoto apparve come una miniera di possibilità, “uno scatolone da riempire” – come scrive Laura Sicignano: e allo sconforto per le carenze si sostituì l’entusiasmo di scrivere su una pagina bianca, di lavorare su una tabula rasa. Così CARGO trovò casa, mise radici. Non solo: stabilendosi a Voltri, contribuì presto al risanamento socio-culturale di quella periferia, estendendo la sua attività sul territorio e configurandosi come impresa culturale.
Un teatro versatile e ricettivo come CARGO, sempre alla ricerca di spunti e suggestioni, non poteva non confrontarsi con il mondo del teatro-ragazzi: nascono, così, lavori come MOWGLI DEL LIBRO DELLA GIUNGLA, che molto attingono al mondo delle favole, spettacoli dai toni lievi, ricchi di musica e colori, pensati a misura di ragazzo, perché – come racconta Laura Sicignano “Scrivo per i bambini spettacoli che mi sarebbe piaciuto vedere da bambina”. (p. 29)
Uno dei fili rossi del volume è la questione dello spazio, centrale nel mondo del teatro: e il Teatro CARGO ha dato prova, in tal senso, di una grande tendenza alla sperimentazione, facendo “teatro fuori dal teatro” – una prassi tipica della città di Genova, ma costantemente rinnovata – realizzando spettacoli in spazi suggestivi e impensati, in grado di assorbire lo spettatore nel tessuto spaziale e narrativo della messinscena.
Nel 2004 è realizzato PARTENZE, spettacolo che rievoca il sogno americano ed i viaggiatori che in esso hanno creduto, raccontato con una lingua su misura, “il gramelot degli emigranti” (p. 37): lo spazio della messinscena è la Gru Maestrale, ormeggiata a Sestri Ponente, che il pubblico raggiungeva tramite un battello, spazio scenico esso stesso. Ancora – lungo la direttrice del “teatro fuori dal teatro” – incontriamo DONNE IN GUERRA, il racconto di sei donne, delle loro storie intrecciate alla Storia, di guerra e di vita, ispirato ai racconti d’infanzia delle nonne, messo in scena seguendo l’itinerario dei vagoni rossi e blu del treno Genova-Casella.
Il viaggio, sia esso itinerario privato o migrazione di popoli, a bordo di un transatlantico o di un furgone che trasporta oggetti di scena – “Appena arrivate a Napoli, in un teatro ai Quartieri Spagnoli, tre ragazze sul furgone fanno difficili manovre nei vicoli” (p. 20), dice la regista – è un elemento qualificante della natura stessa del Teatro CARGO, nonché un leitmotiv della sua produzione. A questo tema è ispirato un ciclo di spettacoli – raccontati all’interno del capitolo programmaticamente intitolato ODISSEE: si tratta di spettacoli nati dall’esperienza del laboratorio teatrale con ragazzi sbarcati in Italia ed ospitati in comunità d’accoglienza per minori richiedenti asilo. “Mele marce” – “così mi furono descritti” (p. 69), scrive Laura Sicignano – questi ragazzi hanno incontrato il teatro, mettendo da parte diffidenze e differenze, forgiando linguaggi e pratiche che gli consentissero di rivendicare una voce per le loro storie: è il caso di Ramat Safi, la cui vita – raccontata e tramandata – diviene il tessuto narrativo di COMPLEANNO AFGHANO, un modo di parlare di sé e, forse, così, guarire, perché, come dice Ramat, “parole come medicine” (p. 76).
Dagli esordi alla chiusura coatta del Teatro del Ponente – in questa “biografia” di una realtà teatrale, come Laura Sicignano la racconta, che spesso s’intreccia alla sua stessa biografia – CARGO mostra una natura prepotentemente camaleontica: il camaleonte, infatti (non a caso, immagine della Stagione 2012/2013), è dotato di straordinaria adattabilità e, grazie ad essa, questa specie è sopravvissuta per secoli, mentre altre specie sono scomparse. Come un camaleonte, CARGO ha vissuto adattandosi ad un mondo in costante evoluzione, evolvendosi esso stesso, con una produzione in osmosi con il contemporaneo o, spesso, “in direzione ostinata e contraria”. Un teatro, dunque, che dialoga con i tempi ma che spesso, pure, taglia fiabescamente e ostinatamente fuori il presente, riservandosi spazi di autonomia e libertà espressiva.
Il profilo che emerge è quello di un teatro ispirato, e popolato, da “fantasmesse”, emigranti, uomini e donne (molte, artefici e protagoniste); un teatro di voci che attraversano i secoli e che lanciano “sassolini nella storia” che giungono a noi, che è nostro dovere raccogliere e, forse, a nostra volta, lanciare ancora, verso il futuro.
E quale spazio migliore per raccogliere la memoria e tramandarla, se non il teatro?
Il racconto dei ventitré anni di vita del Teatro CARGO è corredato da note di regia, comunicati stampa e testimonianze fotografiche che offrono al lettore uno sguardo più ampio sul fenomeno CARGO, una dimensione che la sola parola scritta forse non può restituire, sebbene essa sia – nel caso della prosa di Laura Sicignano – un veicolo potentissimo, capace di creare vivide visioni.
COME SUGHERI SULL’ACQUA
POSSO ANCORA DISEGNARE BARCHE SUI MURI DELLA MIA CASA
di Ariele D’AMBROSIO

A Tangeri, una sera,
LE FARFALLE
2018 Aci S. Antonio (CT)
pagine 96
euro13,00
È un libro di poesie che non può prescindere dal teatro, questo che ho tra le mani, perché il poeta, anche narratore, è prim’ancora drammaturgo tra i più importanti del nostro tempo, come bene dice Marco Lucchesi nel risvolto di copertina sinistra. E senza dimenticare il suo lavoro di sceneggiatore, il primo grado della scrittura teatrale, come l’autore stesso definisce questo modello di scrittura.
Basta poco per trovare mille link sul web che riguardano Manlio Santanelli; ne trascrivo due per tutti:
https://it.wikipedia.org/wiki/Manlio_Santanelli
https://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/santanelli/santanelli_vita
ma spingo il lettore, dopo aver letto la bibliografia sintetica sul risvolto destro di copertina, ad approfondirne la conoscenza non solo su altri link, ma su libri di teatro e di cinema per poterne cogliere subito la complessità, la raffinatezza già visibile e tangibile nei titoli delle sue opere. Ne cito solo qualcuno: Uscita d’emergenza, assai noto, L’aberrazione delle stelle fisse, Disturbi di Memoria.
Sulla copertina sobria, elegante, dal formato comodo, in alto verso il taglio davanti, una farfalla stilizzata con ali come fossero palloncini volanti, in basso il nome della edizione: “Le Farfalle”. E qui si va e si viene in commistioni continue tra la poesia, il teatro e la leggerezza del volo. Perché la poesia è anche tutto questo, mentre non so ancora cosa mi aspetta “A Tangeri, Una Sera”.
Già dall’esergo di Friedrish Schiller, poeta e drammaturgo, anche medico – cosa che me lo fa particolarmente caro per il vissuto tra il diviso e l’unito –, ne ravviso il segno, la pietra d’inciampo, il rigo dove cominciare a percorrere una strada che mi si apre davanti come una freccia precisa e nitida: Quando gli dei erano più umani / gli uomini erano più divini. Il lavoro del poeta è anche quello di saper trovare e scegliere parole che in sintesi indichino un percorso: e subito se ne coglie il dissenso.
Come faccio sempre, vado in quarta di copertina e leggo: «Mi trapassa il mattino con nuove / lame di luce. Ora solo comprendo: / eri tu che, distesa contro il cielo, / immensa fabbricavi la mia notte.». La ritrovo a pagina quattordici, dal titolo Eri tu. Mi attardo un attimo sull’analisi tecnica del testo: una quartina di endecasillabi sciolti con il primo non canonico con dialefe ed ictus sulla settima e decima sillaba, il secondo altrettanto e con ictus sulla quinta/settima e decima, gli altri due a maiori, un enjambement tra il primo ed il secondo verso. Ma questo conta poco, perché il ritmo ed il suono sono naturali e spontanei, mentre appare subito la capacità d’indurre, mentre la si legge, l’emozione aspecifica che invita e invoglia a rileggerla a voce almeno bisbigliata. Ed è qui che i ricordi personali s’annodano a queste parole, e che mi sospendono tra un tormento esistenziale che si espande ed una sofferenza d’amore che si eternizza tra la luce ed il buio dell’aria che respiro.
Tre sezioni per 57 poesie: “da Fogli Ritrovati (1960 – 1970)”; “da Le Due Gemelle (1990 – 2000)”; “da versi DolceAmari (2000 – 2016)”.
Comincio a leggere le prime, e subito alcuni stilemi mi appaiono chiari: versi imparisillabi spezzati da sospensioni impreviste di versi parisillabi, l’anafora e l’epifora in qualcuna come ritornelli da cantare, altre in forma prosastica, quelle che più mi affascinano. Ma è l’uso del ‘tu’ e del ‘te’ la cifra che a me pare più importante. Una poesia colloquiale infatti, che fa dell’io una figura grammaticale ben controllata. E questo è cosa assai importante quando i versi si fanno anche dell’altro e con l’altro, in un tempo in cui l’io narcisistico è nel delirio psicotico dell’autocelebrazione cronica e solipsistica. Ancora di più in un tempo di epigoni ed epigonici, che inchiostrano o digitano soltanto righi in successione.
Segmenti di storie si alternano a riflessioni più vaste, con la capacità di penetrare nella vita vissuta di chi legge con una leggerezza solo apparente: «… Perché questo eterno ruzzolare / dentro alogici dubbi in vesti logiche / se mangiare una pesca o andare al cinema? / E mangiando magari ci si potrebbe imbrattare / la camicia, e forse non sarebbe buffo, / mentre la radio annuncia un’altra guerra? / …». E imbrattare / la camicia con il suo accapo, con il suo e forse non sarebbe buffo, con il suo enjambement che sospende anche per un attimo un tempo ed un luogo perché l’orecchio è distratto dalla guerra che s’infila all’interno di una rabbia: «Ma ieri sera davanti al cinema / c’era un vecchio signore che pestava / con rabbia le cicche gettate dai passanti. / Un paranoico, direte, un paranoico. / Ebbene? Ci sono sempre i tram che passano / stridendo sulle rotaie… Ma se poi / ….». I passaggi sono repentini, la camera che riprende si sposta veloce, come l’occhio umano d’animale che guarda e pensa mille cose in un istante. In questo processo c’è la capacità della buona poesia d’essere sintesi estrema, immagine veloce, riflessione a ponte che cuce e dipana, che aggomitola e cerca.
Come sempre vorrei ogni volta trascrivere le poesie per intero e mi lacero nello spazio esiguo di una recensione, ma è citando segmenti che cerco di descrivere le multiformi direzioni che raggiunge una poetica di alto livello e che spero incuriosisca il futuro lettore.
Poesie che sembrano parlare ogni volta in un teatro, o su un set di un film, e non perché Santanelli è un drammaturgo, ma perché penso che solo la poesia che esprime il suo suono con la voce che dice, da sola o ad un altro-un’altra, esprime il senso del racconto. E cosa è sempre stata la poesia se non il desiderio di eternizzare una storia, grande o piccola che sia, esterna o interna tra corpo e psiche, e sempre per la memoria emotiva di chi legge ascoltando?
Ma questa la scrivo per intero: è bellissima: «Sebbene io sia convinto più di voi / che non abbiamo nessuna possibilità di tornare / su quella veranda / e discorrere amabilmente della pittura di Holbein, / mentre il vento concupisce la magnolia del giardino / e affonda i denti nei suoi fiori di feltro, / sebbene i giornali dicano che quest’anno / ci toccherà fare il pane con farina di loglio / perché è piovuto poco / e la terra non promette se non quello che può dare / o che ha già dato, / sebbene suoni sempre più sgradevole / che io stia profittando del vostro tempo libero / per raccontarvi cose che già sapete, / mentre magari vi aspettavate una novità di grido, / di quelle che da sole riempiono i salotti / e danno al tè delle cinque il sapore di un battesimo, / pure vorrei pregarvi / di non avere troppo a cuore la mia solitudine, / dal momento che la sera posso ancora / disegnare barche sui muri della mia casa / e immaginare che un giorno prenderanno il largo / portandosi via l’ultimo poema, / quello che appena si ha il tempo di pensare.». La solitudine che pensa continua a viaggiare con barche disegnate sui muri, squarciando gli stessi, per nuovi percorsi da inseguire, nuove scoperte da cercare. Anche qui la terapia delle parole, con la tenerezza del mondo e per il mondo, della vita e per la vita.
Nella solitudine, «Di me poche parole / solo per affiorare dal silenzio. / …», fanno capolino le condizioni sociali, la guerra, ed è qui che ritrovo a pieno il dissenso di Schiller: «… Ho ritagliato un giornale che dice: / “La sete, ansietà del Duemila”. / Mi chiedo se basteranno / il Nilo e il Gange fino a domani.». «Anelavi ad un mondo geometrico / da distendere sulla tua pagina / in chiari teoremi di luce, /… / Ma non avevi previsto il muro d’ombra / della poesia, / e ti franarono i numeri addosso.». Dove Il pi greco del titolo non risolve l’apparente armonia delle formule e delle geometrie, perché la poesia fa vedere anche il suo muro di denuncia irrisolvibile con la sua ombra che un po’ ti protegge e un po’ ti oscura. Ed ancora da Il soldato morto: «Con la divisa che gli marciva addosso / tornava dalla guerra il soldato morto. /… / E giunto a casa trovò suo padre / che gli disse: “Soldato non è giusto venire / a rimestare nella memoria dei vecchi!” / Allora egli riprese la via dei campi / perché ai morti non resta altro / che andarsene in giro per il mondo / in cerca di una seconda morte.». E non ci poteva essere finale più incisivo per dire di guerre mai spente anche nella memoria degli uomini vecchi, e che il soldato istruito alla guerra è già morto ed è morte nella stessa parola di soldato. I poeti, anche da lontano, anche in tempi diversi, viaggiano su binari paralleli ed ho piacere che Manlio Santanelli sia accanto a Yehuda Amichai che nella sua Ninna nanna così dice descrivendo la guerra: … Togli a un bambino la sua ninna nanna, / e lui dormirà lo stesso, e crescerà lo stesso. // Togli a una ninna nanna il suo bambino / e lei prosegue sola per il mondo / e infine lo raggiunge / e lo addormenta per sempre.
Riprendo le anafore e le epifore di alcune, che si spingono verso chiuse finali che spiazzano e stupiscono con la loro amara ironia fino al crudele sarcasmo, mentre Le sofferenze d’amore rimandano al sempre, tra Saffo e Catullo: «If you’ll come with me, / se tu verrai con me alla fine del mondo, /… / if you’ll come with me to the end / se tu verrai /… / if you’ll come, / se tu verrai con me alla fine, / … / if you’ll come, se tu verrai / … / in questa lisa notte d’estate, / se non ti mancherà il cuore di venire, / if you’ll come, / se tu verrai con me alla fine del mondo.». Ed ancora in Ma non so con chi, dopo otto Vorrei per otto terzetti che si concludono ogni volta con ma non so con chi: «… Vorrei essere amico di qualcuno / che non si fingesse un altro, / ma non so con chi.». O come i cinque Volevo per altrettanti terzetti conclusi ogni volta con ma si è fatto tardi, perché «… Volevo da una donna un bacio come / il materno bacio della buonanotte, / ma si è fatto tardi.».
Ma per attardarmi solo un po’ sull’ironico-grottesco, ecco Un bel gesto del rabbino Jacob che «… non seppe mai / che quel bambino era il piccolo Adolf / di casa Hitler.». Così come tutto quello che, nel Il tuo nome, porta ancora il tuo nome: L’alito delle …, Il luccichio dei …, La rondine che …, La casa che …, Lo spumeggiare del …, Il dolce languore dei …, La marina spopolata, si conclude con «Soltanto il letto in cui ora dormo da solo / non porta più il tuo nome.». E mentre leggo sorrido, persino rido: «… Da quella posizione lei poteva vedere / di lui niente altro che la guancia destra. / Fu così che giorno dopo giorno lui imparò / a piangere soltanto con l’occhio sinistro. // (E non seppe mai che anche lei imparò / a piangere soltanto con l’occhio destro)».
Finisco con una poesia che mi ha assai intenerito e che mi ha portato verso la levità di quelle filastrocche popolari che si leggono qua e là all’interno delle “Fiabe Italiane” curate da Italo Calvino e che mia madre mi leggeva quando ero piccolino. Sono sette strofe di due versi ciascuna: «Un mantello di parole voglio cucire / per coprire le tue spalle di ambra. // Una veste di parole voglio imbastire / per fasciare il tuo corpo di gelso. / …». E lascio al futuro lettore la delicatezza delle altre strofe e l’abbraccio protettivo dell’ultima per l’amore della donna amata.
Abbiamo percorso molte strade, per scoprire una poetica che si connota in modo ben definito e riconoscibile. Mentre le note, le musiche di queste parole-suono ci trasportano in mille direzioni emotive e senza che finiscano mai di stupire. Poesie che, con una apparente leggerezza, passano e penetrano, e ci accolgono con l’emozione e il desiderio di ascoltarle ancora.
Napoli giugno 2023