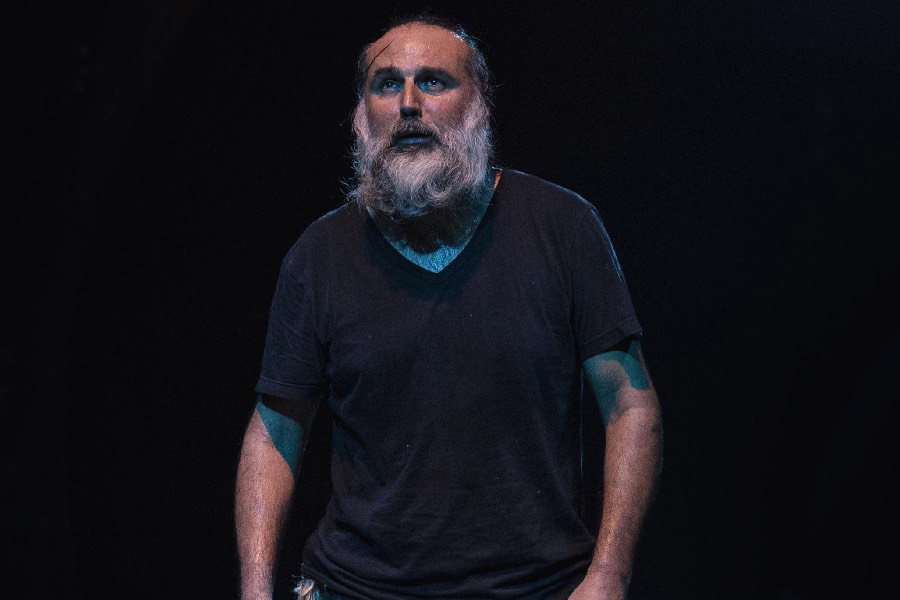Guida Galattica per i Lettori | Maggio 2024

- AMICO ROMANZO L’urbanistica onirica di un’infanzia di periferia di Gabriella NOTO
- SIPARI APERTI Il canone letterario gesuitico italo-iberico di Antonia LEZZA
- COME SUGHERI SULL’ACQUA Ogni poesia implora un respiro che la dica di Ariele D’AMBROSIO
AMICO ROMANZO
L’URBANISTICA ONIRICA DI UN’INFANZIA DI PERIFERIA
di Gabriella NOTO

L’urbanistica onirica di un’infanzia di periferia
“La necessità di uccidere i padri è un’invenzione dei maschi, io, femmina, mia nonna me la mangerei per seppellirmela dentro e srotolare il cordone ombelicale, dalla coda di questo Novecento fino al ventunesimo secolo. Racconteremo insieme.”
Napoli è una di quelle città che sa stare nei romanzi. Sul protagonismo letterario ha un talento suo, camaleontico e innegabile; Napoli abita bene le pagine, le soggioga al suo potere di protagonista prepotente e inaspettata.
Ne hanno dato dimostrazione penne sapientissime, da Curzio Malaparte ad Anna Maria Ortese, da Ermanno Rea ad Erri de Luca e Domenico Starnone. Ambientare una storia a Napoli vuol dire assumersi la responsabilità di un’identità trasformista e indomabile, angusta e immensa, splendente e nauseante.
Nel suo romanzo di esordio, Stefania Spanò, riconosce questa maestria e se ne appropria; modificando alle sue esigenze di narratrice l’urbanistica cittadina.
Il cuore del racconto è tutto in una precisa zona di periferia: Secondigliano che nasce, pasce, cresce in una disordinata e speranzosa giovinezza, viene, infine, sconvolto dal terremoto del 1980 e dalla infilata di scellerati maneggi urbanistici che di quella catastrofe furono la triste figliolanza.
Secondigliano è tutto il mondo della piccola Stephanie, che il quartiere se lo deve guadagnare un metro alla volta sottraendosi alla clausura in cui la vorrebbero tenere la mamma e le zie. Una mala educaciòn che progredisce con l’avanzare dell’esplorazione delle strade di Secondigliano e con l’incontro con la sua gente.
E, dal momento che tanto le strade e i palazzi, quanto i suoi abitanti, appaiono come un’enigma complicato e respingente, Stephanie è costretta, lei che è “nata moscia”, a diventare abilissima nel seguire scie e tracce.
Osserva il mondo e le persone fin nei più sottili indizi, raccoglie storie.
In questo lavoro intimo e segreto, disturbato da un mondo di adulti che hanno sempre altre urgenze, Stephanie si riconosce, suo malgrado, affine e compagna di una nonna insopportabile e temuta, che passa per pazza.
Nannina è vecchia e sboccata, ma conosce il segreto unico per afferrare il senso della realtà: raccontarla. Racconta “stroppole”, “sciocchezze” con talento istrionico di attrice consumata. Strappa ai morti i “cunti” che è necessario raccontare ai vivi, perché comprendano verità per le quali non hanno né voce né parole.
Questa nonna, aggressiva e insolita, scavalca ogni dover essere: è una donna libera e impossibile, che non chiede permesso a nessuno per portare avanti la sua personale opera di trasformazione della realtà, e tanto le sue sciocchezze sono un fatto grave ed eversivo, che sarà necessario murarla viva e chiudere in manicomio lei e la sua lingua che racconta.
Monito che la vita non è quella che crediamo, un accidente bio/cronologico fatto di eventi e tappe ordinate, la storia proposta da Stefania Spanò segue il ciondolare incompreso e incomprensibile della sua protagonista e l’esplosione di istanti terribili e totali. L’autrice rapisce un senso altro delle cose, filtrato dagli occhi di bimba di Stephanie e dalla testa di vecchia di Nannina: un macabro scambio di siringhe tra eroinomani appare un gioco misterioso e innocente, la notte del terremoto del 1980 è uno squasso di liberazione, che libera i poveri malati del “Leonardo Bianchi”. Ciò che accade è già nel “cunto”: la realtà simultaneamente diventa il racconto di sé, un’origine continua di significati e travisamenti, moniti, maledizioni e profezie.
Nannina è un romanzo emozionante perché è commossa e partecipe la voce della sua autrice. Senza alcuna retorica, Stefania Spanò racconta il suo quartiere e la sua gente con affetto autentico, riuscendo a ricostruire una realtà fatta di segreti confini, di piani paralleli continuamente intrecciati e restituiti ad una narrazione asciutta e vivissima. Un labirinto di vivi e di morti, di sani e di pazzi, di “mastrosuocci” e persone oneste, di povertà e bellezza, di terremoti e amori adolescenziali, dove ognuno appare per una cosa e per il suo esatto contrario nello stesso momento. Strumento del racconto è la lingua che ci propone l’autrice, in crescita come la piccola protagonista che arricchisce il suo napoletano familiare con l’italiano che impara sempre più e sempre meglio andando a scuola. A questo bilinguismo, così comune a Napoli, si aggiunge però un cuore pulsante e incontrollabile di altre parole inventate e sensose: le parole dei “cunti”. Un lessico di fiaba e di incantesimo che buca la realtà e la fissa rendendola accessibile fin nel suo nucleo più segreto.
E poiché i “cunti” iniziano da un principio certo, e conoscono il valore dell’origine, l’autrice, in questo suo “cunto” di esordio, dedicato al quartiere di Secondigliano, ricostruisce con attenzione feroce la trasformazione di una periferia, popolare e operaia, in ghetti disumani fin nelle scelte toponomastiche: “Parco Verde” di Caivano, le “Salicelle” di Afragola, la “167” di Secondigliano, “Taverna del ferro” di San Giovanni a Teduccio, il rione “25/80” a Chiaiano.
Un invito severo ad abbandonare pietismi e giudizi, ed a perseverare nello sforzo umano di cercare e trovare la propria voce per restituirsi integri alle contraddizioni e alle ingiustizie, abbracciando la vita che procede, ovunque, splendida, spietata e misteriosa.
SIPARI APERTI
IL CANONE LETTERARIO GESUITICO ITALO – IBERICO
di Antonia LEZZA

Il canone letterario gesuitico italo-iberico
Il volume curato da Michela Graziani e Salomé Vuelta García, s’inserisce tra gli studi sulla storia e la cultura della Societas Iesu che, a cominciare dalla ripresa verificatasi negli ultimi decenni del secolo scorso, hanno fin qui prodotto una corposa bibliografia. Come evidenzia Alessia Castagnino nella Premessa, «i saggi che compongono il volume sono un ottimo esempio di una matura consapevolezza delle direzioni lungo le quali si muove ai giorni nostri la storiografia […]; non meno importante, essi hanno il merito di portare all’attenzione degli studiosi fonti meno note, ma particolarmente utili per una ridefinizione o discussione del canone letterario gesuitico (p. VI).
Una delle direzioni di ricerca è rappresentata dalla traduzione, alla quale si lega, nel volume, il concetto di adattamento. Insieme o individualmente, traduziene e adattamento permettono alle opere – si spazia dai libelli alle opere teatrali – di essere ricollocate in contesti diversi da quello d’origine. Va qui ricordato come adattamento sia una delle parole guida dell’attività missionaria dei Gesuiti. Il loro è un adattarsi basato sulla conoscenza delle culture altre come mezzo per arrivare alla comprensione e allo scambio. Ad una lontana terra di missione, la Cina, fa riferimento Michela Graziani nel suo: Innocentia victrix e la situazione spinosa dei padri gesuiti nella Cina del Seicento. Sulla base di una precisa ricostruzione del contesto difficile nel quale vivevano e operavano i gesuiti, l’autrice analizza attentamente, anche dal punto di vista linguistico, Innocentia victrix, un libretto ‘difensivo’, scritto in latino con passi nei dialetti locali, che circolò anche in Europa. Esso è d’incerta attribuzione e fu composto in occasione d’un processo che andò avanti dal 1664 al 1675. Sotto accusa alcuni padri e con loro la religione cristiana; vi si difendono al contempo l’innocentia di quest’ultima e l’opera missionaria dei gesuiti; una difesa che purtroppo non sortì l’effetto sperato.
Ancora accuse nel saggio di José Eduardo Franco, Para um cânone da literatura antijesuítica: propaganda, tradução e literatura de combate aos jesuítas em Portugal. Che esista un antigesuitismo di vecchia data è assodato. La letteratura che in senso lato si può chiamare antigesuitica circolò in Portogallo, soprattutto nel periodo pombalino (1750-1777); i generi, rileva Franco, sono tanti e vari e rappresentano una vera e propria «literatura de combate» (p. 82). L’autore esamina attentamente le opere, che circolarono anche in traduzione, fondative di un vero e proprio mito al contrario secondo il quale i gesuiti, la loro filosofia di vita e la loro azione sono il negativo della realtà, la decadenza. Anche il teatro fu usato come mezzo di propaganda contraria. Nel 1770, per esempio, Il tartufo di Molière servì di modello a Leonardo Pimenta per A ambição dos tartufos invadida, un’opera rappresentata a Lisbona, della quale si può immaginare il contenuto.
È proprio sul teatro, sulla produzione teatrale gesuitica e sulle sue caratteristiche naturalmente, che fa centro la parte più cospicua del volume. Come si sa, si recitavano nei collegi aperti dalla Compagnia di Gesù in molti paesi europei e non solo, soprattutto tragedie a scopo didattico ed edificante. Arianna Fiore, nel saggio: San Luigi Gonzaga nel teatro gesuitico spagnolo e italiano (ss. XVII e XVIII), esamina attentamente un corpus di pièce dedicate appunto a un personaggio esemplare, il santo gesuita san Luigi Gonzaga; siamo di fronte a testi non molto conosciuti, il che già di per sé costituisce un dato positivo. Sono opere che, senza voler dare alcun senso negativo al termine, possono essere definite d’occasione; l’occasione è cerimoniale, una ricorrenza o addirittura la canonizzazione. La studiosa procede a un attento confronto tra testi di area iberica e di area italiana; essi sono conformi all’estetica del luogo e del tempo, rispettivamente la Spagna del XVII secolo e l’Italia del XVIII, ma «sono analogamente pervase dal fine educativo e religioso che caratterizzò tutto il teatro gesuitico» (p. 58).
Ancora il confronto, questa volta sottinteso, e soprattutto l’adattamento, nel saggio di Salomé Vuelta García, I gesuiti e il teatro del Siglo de Oro nell’Italia di primo Settecento: le traduzioni di Antonfrancesco Bellati al Collegio dei Nobili di Parma, dedicato alla traduzione di alcune opere spagnole del Siglo de Oro, prodotte nel «prestigioso Collegio dei Nobili di Parma […] affidato alla Compagnia di Gesù, che divenne una delle istituzioni accademiche più celebri d’Europa» (p. 60).
Punto di partenza e oggetto di un primo, necessario ragionamento, è il ruolo giuocato dal teatro nella formazione, che si voleva completa, assicurata agli allievi dei collegi dei gesuiti. In tale ottica il teatro è, possiamo dire, attivo, è strumento e i testi teatrali che, vale la pena ripeterlo, venivano rappresentati, talvolta in traduzione, in paesi diversi, diventano a loro volta strumenti. Nella traduzione potrebbe però celarsi un’insidia, allorché l’adattamento a contesti linguisticamente, ma anche culturalmente e politicamente diversi, apre la strada ad un controllo dei testie da mettere in scena.
Per chiudere, un saggio, quello di Mirella Saulini, Frammenti di teatro, e non solo, da un manoscritto gesuitico, che non tocca il tema della traduzione e sfiora quello dell’adattamento, allorché rileva come, già dalla cosiddetta Ratio Studiorum borgiana (1569), si raccomandi la conservazione dei testi, nel caso quelli poetici e teatrali, in vista di un possibile nuovo utilizzo degli stessi. L’autrice, partendo dalla meticolosa indagine della fonte, il manoscritto APUG 1143, conservato presso l’Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana, formula, sulla base di quanto emerge dai testi, qualche ipotesi sulle circostanze in occasione delle quali essi potrebbero essere stati utilizzati. La maggior parte dei testi è inedita – si segnala il lungo De duplici triumpho Divi Joannis Baptistae, in distici elegiaci – e potrebbe dunque essere un punto di partenza per nuove ricerche. Una tendenza, quella a stimolare tanto l’approfondimento dei numerosi temi proposti, quanto la curiosità di verificare se altre opere, sia in ambito iberico che italiano, presentino le medesime caratteristiche di quelle esaminate, sembrerebbe uno dei tratti distintivi, e non il meno importante del denso volume curato da Michela Graziani e Salomé Vuelta García.
COME SUGHERI SULL’ACQUA
OGNI POESIA IMPLORA UN RESPIRO CHE LA DICA
di Ariele D’AMBROSIO
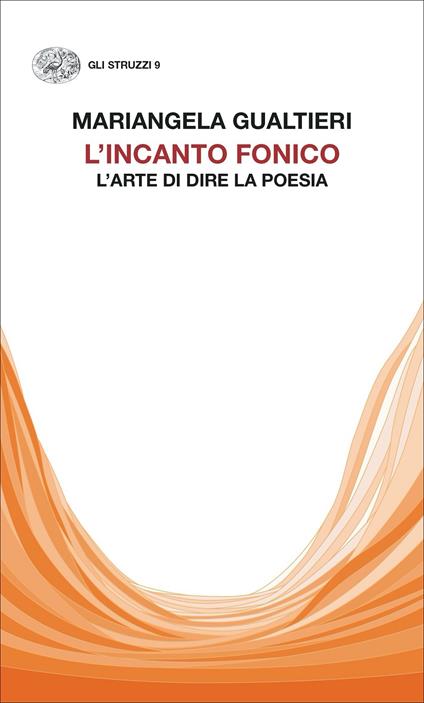
L’Incanto Fonico
L’Arte di Dire la Poesia
Gli Struzzi – Giulio Einaudi Editore, 2022 Torino
pagine 164
euro 14,00
Info:
https://it.wikipedia.org/wiki/Mariangela_Gualtieri
Ogni poesia implora un respiro che la dica
Ed ecco un libro strano, un libro di strane poesie. Poesie? Il titolo è affascinante: L’Incanto Fonico con il suo sottotitolo: L’Arte di Dire la Poesia. E in copertina c’è un’onda concava che ne fa immaginare altre due convesse alla destra e alla sinistra. Un’onda in divenire, fluida come l’acqua, trasparente come il tempo. Il colore sono strisce di gradazioni d’arancio, un arancio morbido. Saranno frequenze di suoni, note, rumori. Ma accoglienti in quell’abbraccio di curva che contiene uno spazio bianco d’aria e di respiro. Sì: la laringe, il cavo orale, la lingua, il palato molle, quello duro, i denti, le labbra, ed anche la maschera fatta delle cavità dell’osso mascellare, di quello frontale, di queste ossa fatte anche di insenature risonanti, e prima ancora i polmoni, la trachea. Sì, perché questo è lo strumento musicale che la natura ha donato all’essere umano fin dalla nascita; da qui è nata la parola, il canto, da qui il linguaggio che ci fa parlare e scrivere, e dire le poesie.
Vado in quarta di copertina e leggo: «Ogni poesia implora un respiro che la dica», e nell’esergo introduttivo di Emily Dickinson: una parola è spacciata / quando è pronunciata, / qualcuno dice. / Io dico che proprio / quel giorno / comincia la sua vita. Bene, non mi sono sbagliato guardando la copertina e l’impatto emotivo di rimando al titolo. Il progetto grafico di collana è di Ugo Nespolo, e va citato perché tutto concorre al piacere di una scoperta. Nel risvolto di destra apprendo che Mariangela Gualtieri è persona di teatro e di letteratura, non poteva essere diversamente. Quando la poesia vuole voce e corpo non si prescinde dal teatro, perché diventa teatro, è teatro. Un luogo dove il pubblico ascolta, dove chi dice è pubblico di sé stesso che si ascolta mentre dice.
Mi aspetto allora subito di incontrare Amelia Rosselli – ineludibili i suoi Spazi Metrici del 1962 –, Carmelo Bene, ma anche Gassman, ed altri ancora, ma primo fra tutti Paul Zumthor, e resto favorevolmente sorpreso di trovare questi riferimenti e fonti di letture nel finale intitolato Note e gratitudine. Così come nel risvolto sinistro il duende del mio adorato Federico García Lorca, e il breve appunto ad una attorialità in poesia che legge il verso sulla sua componente razionale e di significato, trascurando tutto il resto, come dice la stessa Mariangela Gualtieri citando Zumthor. E che i lettori mi perdonino questa autocitazione, di chi da anni studia appassionatamente il capitolo della Poesia Orale secondaria Contemporanea che ho sintetizzato con la sigla POC. Secondaria perché non estemporanea come la primaria, e dove molto entra in connessione, in commistione: l’esperienza sperimentale anche della poesia sonora, dalle avanguardie storiche alle neoavanguardie, con quella lineare, e che dalla ricerca sulla scrittura si espande a quella sul modo di dirla, di farla ascoltare. Una ricerca e uno studio, che oggi, a mio dire, dovrebbe coinvolgere non solo l’attore, ma anche il poeta che desidera far parte della POC.
Un libro che ci parla del dire, di come comunicare anche il dire del silenzio, che non è né un paradosso né un ossimoro, ma che parla come pausa tra versi e strofe, e parla anche in quella impercettibile della punteggiatura che Gassman ha sempre definito come grafia della voce. D’altronde è bene che si studi anche la voce mentale della lettura in silenzio, per poterla poi esprimere come suono udibile, parola udibile, canto. Perché una poesia è una partitura di parole che non scinde mai il percorso storico del suo significato dal suo significante, compresa l’esecuzione con le sue possibili nuove connotazioni nel tempo che cambia. Ed è la stessa autrice che ci conferma quanto detto nel suo prologo intitolato Poetica e arte dell’oralità: La poesia chiede libertà dai vincoli semantici, chiede di farsi viva voce, vuole essere suonata, o cantata, proprio come ogni spartito musicale, fino ad arrivare a quello che Amelia Rosselli chiamava «l’incanto fonico».
Per questo, e con compiacimento sottolineo l’importanza della τέχνη, quando Mariangela Gualtieri così bene dice dell’importanza del fonico che è figura fondamentale in questo ambito, una presenza quasi sempre dotata di alta capacità di ascolto e di un orecchio musicale che si lascia facilmente appassionare dalla poesia. Non è facile trovarne, vanno scoperti, è una fortuna trovarne, aggiungo.
Sì, L’Incanto Fonico ci parla di tutto questo dividendosi in capitoli dai titoli precisi: Poetica e arte dell’oralità già citato, Questo ci tocca, Il silenzio, Sulla poesia, Il metro, La voce, Come mettersi lí, A memoria, by heart, par œur, Tecnologia sacra, La paura, Il respiro, Il pianto, L’attenzione, Nota e Gratitudine di cui ho già accennato. Ma voglio subito brevemente indugiare sulla forma di queste scritture, per poi abbandonarla subito, perché il senso di questo libro lo trovo altrove: nelle sue riflessioni, nel suo essere una sorta di saggio in “odor di poesia”, una “poesia saggistica” così come la si definisce nel risvolto di sinistra, e nel desiderio, direi nella passione di spiegare l’importanza del suono delle parole, e delle parole di una poesia detta, ascoltata, non solo letta.
Ma perché all’inizio ho scritto strane poesie? Poesie? Perché sono di fatto riflessioni anche emotive sul tema, e si oscilla a definirle tra poesie in forma prosastica e segmenti di prosa poetica. Ma la vexata quaestio è oramai obsoleta. Certo che non ci sono spezzature o enjambement, e nemmeno accenti e rime, e forme metriche, certo è che ci sono accapo come capoversi non di versi, e trattini di accapo sillabici perché non si è usata la forma automatica di scrittura computerizzata che giustifica uno scritto. Pertanto mi curerò di trascrivere alcuni testi o estrapolati di essi, tra le virgolette basse, e d’inserire un doppio tratto obliquo tra un segmento di scrittura ed un altro della pagina successiva e per un motivo preciso: ogni capitolo raccoglie un unico discorso che da una pagina continua nell’altra.
Subito da Questo ci tocca: «Questo dire il verso. Un fare nell’ordine del poco e del niente, del quasi-niente. // Questo dire il verso. Regno di sottigliezza, di appena, margine fra esperienza e salto fuori esperienza, fra ragione e magma prima di quella, fra volontà e abbandono. // … Sì, può essere condiviso con chi vuole tentare questa impresa del dire. Dire la poesia. // … Così ogni verso. Ogni poesia implora un respiro che la dica. Essere detta. Detta per bene in una sua ritmica e melodia e timbrica e interni silenzi. // … // Forma sonora del verso: non è sua veste. Non veste del verso ma corpo, suo corpo. Parte di corpo nascosta, come parte intima. Va rivelata.». E subito quel niente, quel quasi-niente, mi riporta a Carmelo Bene, al suo concetto di assenza, al voler a tutti i costi scarnificare dagli umori più abusati la parola dei versi. Non veste del verso ma corpo, e come non ricordare Leo de Berardinis, – altro grande autore-attore drammaturgo sperimentale – che parlava dell’attore come poeta “fisiologico”, intendendo con questa espressione, la capacità, il dovere d’immergere le parole nel corpo.
Ancora da Il silenzio: «Poesia è anche il silenzio che precede e che segue il verso, silenzio che precede e che segue ogni parola dentro il verso. Silenzio dentro ogni parola.». E i segmenti dello scrivere sul dire sono immersi nel vuoto tipografico della pagina che bene esprime il senso “materico” esterno ed interno del silenzio. L’odore mentale, il sapore mentale, il tatto mentale, la voce mentale di chi legge in silenzio, di chi legge il silenzio, le pause dei silenzi, nei silenzi.
Sulla poesia: «Qui chi ha scritto è stato in esercizio plenario di auscultazione, spalancato in una attesa insensata del niente da cui sgorgano le strane parole. // … E guarda! ciò che ne scaturisce è alta ragionevolezza più alta. Filosofico canto. // … Essa arriva come dono: «dono fatto agli attenti, dono che implica destino». …». E qui la scienza e la filosofia s’incontrano e s’incrociano. Il cuore abusato nelle tachicardie dei sentimenti, esprime il suo sincizio di autonomia nervosa che rimanda all’organo dove si nasconde la mente. Viene auscultato, nell’attesa tra i suoi toni, per un destino che rilancia l’esistere nel suo circolo di vita, ma anche nel suo cerchio sperato oltre il cielo. Ed è bene dire quanto tutto questo sia un dono fatto agli attenti, perché la poesia esige attenzione e desiderio.
Altre importanti indicazioni nel Il metro: «Lí dove la poesia ha metro, indagare la particolarità ritmica di quel metro. … // … su accenti vari e mutevoli e geometrici e perfetti di endecasillabo. … // Dove metro non c’è, se metro si nasconde, sapere che c’è. … // Dove tutto è rotto spaccato, poesia diventa esperta di alto rammendo. Di saldamento. Di aggancio. …». La poesia che almeno tenta di rammendare le faglie, e ricucire i tagli e Dove metro non c’è, se metro si nasconde, sapere che c’è. E non c’è migliore sintesi, citando Aldo Menichetti che così bene ci dice: nelle adibizioni più alte e rigorose, non pigre né meramente antagoniste e contrappuntive nei confronti della vecchia metrica, la loro «libertà» non risulta anarchica o gratuita («soltanto un cattivo poeta potrebbe accogliere il verso libero come una liberazione dalla forma», Eliot; in fondo, quali che siano le sue convinzioni teoriche, il vero poeta regola sempre «son chant sur une loi factice, plus ou moins stricte, dont il s’instaure le prisonnier volontaire», Waltz 217): la loro forma si autolegittima, facendosi portatrice di una «propria» misura, sicché assumono anch’essi per il lettore quello stesso carattere di necessità (insostituibilità) che contraddistingue nei suoi risultati migliori la metrica tradizionale.
Estrapolo da La voce: «… Nuda voce non impalcata non accessoriata non potenziata. Nuda voce più nuda. //… // … Allentare antiche trappole – imprigionata lí è l’alga voce.», ed ancora da Come mettersi lí – e mi diverte l’accento acuto, ogni volta sulla ‘i’ di lì. Sarà una nota acuta quella ‘i’, un grido, un sibilo? –: «… Strapparla alla letteratura e farne natura, suono che agisce e trasforma. Canto. // … // Lasciare zavorra di pensieri. Lasciare desiderio di compimento, di buon risultato. Rinuncia. Niente esito. // … // Così attenta nell’udire ciò che vai pronunciando: un capello che cade è tonfo d’universo. …». E mi risuona Io so / che un chiodo nel mio stivale / è più raccapricciante della fantasia di Goethe! Mi risuona la voce di Bene mentre diventa corpo in Majakovskij. I rimandi a Carmelo Bene sono continui ed è giusto così per chi vuole che la poesia sia corpo e voce.
Vado avanti per capitoli lasciando per ultimo A memoria, by heart, par œur. E c’è un motivo. Tecnologia sacra: «Microfono, fili, casse acustiche da cui fuoriesce la voce. Amplificatore. Tecnologia sacra edifica architetture sonore sontuose e sottili. Cattedrali di suono. Magnifiche. Abbaglianti. Incantatorie. // La lingua tocca il palato e stacca, produce suono enorme. Saliva scricchiola. Respiro minimo diviene aria grande che tuona. È corpo che vuole esserci, dentro la parola.». La paura: «… Tenere vivo l’incanto, non fare cadere con tosse, con grave pensiero, con preoccupazione, con filo di catarro che fa stecca, …», e subito dopo nel Il respiro : «Ascoltare il proprio respiro: in esso risiede un’altra radice. // … // … Prima di proferire il primo verso. Respiro – come?». Nel Il pianto: «… Come quando la neve appare. Come, svoltando l’angolo, luna improvvisa piena.». Nel L’attenzione: «Di essa – fino qui – si è detto. Di essa attenzione.». C’è un ritmo spezzato, tronco, senza rotondità, scevro da carezze e mugolii. È un libro che indica percorsi senza cercare scorciatoie né mediazioni. Si esige l’attenzione: N.B. Questo invito è rivolto esclusivamente a chi sia, almeno per i prossimi n° 6 mesi – orfano di mondo e ritenga necessità frequentare questa prassi oltre il dire – oltre il canto del soggetto (una vocalità basata sul parlato d’opera – intonazione – recitar cantando – flusso del verso – metrica-prosodia – staccato – etc.). Così come Bene ha già indicato da tempo.
Concludo con A memoria, by heart, par œur: «Imparare a memoria. Esercizio di furiosa attenzione. Provo più volte e non succede. Penso: non riuscirò. … Poi ecco, ogni parola è con me … // … // E il corpo. Libero anch’esso dalla schiavitù del foglio …». Per finire con una piccola chiosa, del già più volte citato: Quindi questa è la funzione del leggio, questa è la funzione del leggere, non perché uno abbia perso la memoria, bisogna perdere la memoria, invocazione per stare in questa fascia di delirio. Ma perché ricordo questo suo definirsi in una scelta? Perché preferisco lasciare la pratica della memoria all’attore, mentre il dire leggendo al poeta, che possa così ancorarsi all’attenzione della parola da dire evitando le derive enfatiche della memoria che rischia ogni volta di dimenticare la sua gola. E sottolineare così anche la genesi della scrittura preesistente, una scrittura, si spera, anch’essa di ricerca.
Infine, dove riconoscere queste poesie senza il punto interrogativo? Nell’idea di fare della riflessione sul dire, – e questa è una novità – uno scritto amorevole ed emotivo, col desiderio d’indicare strade e percorsi necessari. E utilizzando anche un certo lessico, una specifica forma sintattica, come fosse di per sé amplificata dalla maschera teatrale che è propria di questo poeta. E concludo con la speranza che Mariangela Gualtieri possa ripubblicare L’incanto Fonico con un CD-audio allegato o un QR-Cude, in modo da raggiungere il suo dire.
Napoli aprile 2023