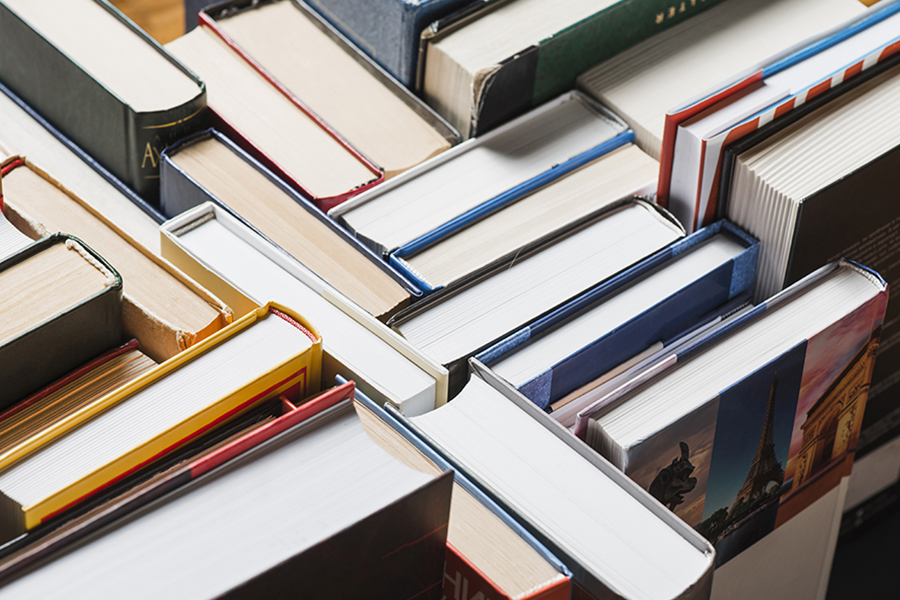«Non ti scordar di me». Il fiore che ti mando l’ho baciato

a cura di Luca VACCARO
Inizio col ringraziare Alberto Beltramo e Silvia Bartolini per aver generosamente accolto, nel pomeriggio di venerdì 7 marzo 2025, a Bologna, presso la Biblioteca di Casa Lyda Borelli, la presentazione del «Quaderno dell’Associazione Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo» Il fiore che ti mando l’ho baciato(1). La loro disponibilità ha reso possibile un’occasione di approfondimento e di confronto sul valore storico-culturale dell’opera. Un ringraziamento particolare è rivolto agli ospiti che hanno preso parte a questa iniziativa: Elvira Buonocore, Antonio Grimaldi, Gerardo Guccini, Antonia Lezza e l’attrice Anna Rita Vitolo, che con la sua interpretazione ha restituito la dimensione drammatica del Fiore, valorizzandone la potenza espressiva attraverso una resa scenica di grande intensità.
Riprendendo quanto esposto durante l’evento, vorrei tornare al punto di partenza della nostra riflessione: in che modo la storia di due innamorati può dare voce alla macrostoria della Grande Guerra e lasciare un segno nel presente? La pubblicazione delle lettere spedite da Francesco Fusco a Stamura Segarioli – da cui è nato il testo teatrale Il fiore che ti mando l’ho baciato (Napoli, Libreria Dante et Descartes, 2024; d’ora in poi = Il fiore), scritto da Elvira Buonocore e Anna Rita Vitolo, e messo in scena dal regista Antonio Grimaldi – rappresenta un esempio significativo di come l’arte possa trasformare una vicenda personale in un racconto universale, sottraendola al tempo e rendendola viva nella memoria collettiva. Trattandosi di lettere, si potrebbe pensare che la relazione tra Stamura e Francesco segua le dinamiche di un romanzo sentimentale, scandito dalle gioie e dalle incertezze tipiche di una storia d’amore, fino all’epilogo tragico della morte di Francesco, avvenuta il 2 agosto 1915 a Belluno, poco prima dell’entrata ufficiale dell’Italia nella Prima guerra mondiale, il 26 agosto. Tuttavia, confinare Il fiore entro i margini di un romanzo della sensibilità significherebbe ignorarne le sfumature più profonde. Oltre al valore documentario, le lettere raccolte nel testo teatrale custodiscono infatti testimonianze delicate, intime, capaci di restituire la dimensione orale di uno scambio epistolare in cui parole mai pronunciate si sono fissate nella scrittura. Riportare oggi alla luce quelle parole significa, in un certo senso, praticare una forma di «filologia commossa» che restituisce voce e corpo alla storia di due innamorati, iniziata nel 1913 a Castel Giorgio(2). Lei, Stamura, maestra elementare, nata nell’agosto del 1892, di ventuno anni; lui, Francesco, tenente medico, nato nel febbraio del 1881, di trentadue anni. Pur avendo una maturità intellettuale simile, la differenza di età induce però Francesco a sentirsi spesse volte in una posizione di superiorità nei confronti della compagna, soprattutto nelle fasi iniziali della relazione. Convinto della profondità dei suoi sentimenti (ivi, p. 36: «io mi assoggetterò a tutto quello che vuoi»), il giovane si sente in diritto di riprendere Stamura ogni volta che la ragazza mette in dubbio la sua maturità di uomo; desidera che la sua amata sia indipendente e priva di timori, nonché capace di affrontare il mondo con coraggiosa sicurezza(3).
Al di là della fermezza di volontà, ciò che Francesco chiede con insistenza a Stamura è però considerazione e rispetto(4). Eppure, se da un lato il ragazzo esige dalla compagna una completa condivisione delle sue incertezze e dei suoi turbamenti, dall’altro è proprio lui a rivelare una maggiore fragilità, lasciandosi spesso andare a una vena vittimistica e a eccessi di gelosia(5). Non di rado poi, Francesco accusa Stamura di superbia, di freddezza o di scarsa generosità. In questo gioco di equilibri emotivi, alcune parole emergono con particolare forza nelle sue prime lettere; «superbia», «possesso», «illusione» sono infatti concetti che sostengono la funzione prevalentemente fàtica della comunicazione e che contribuiscono a delineare la concezione dell’amore secondo Francesco: un sentimento totale ed esclusivo, intriso di «santità», «tenerezza» e «sacrificio», che per lui si configura come «eterna poesia della vita» (ivi, pp. 36; 65): «Un’emozione puramente fisica è cosa passeggiera non un sentimento… un patrimonio di tali ricordi non passa non si dimentica» (ivi, p. 69).
La natura amebea ed evocativa del genere epistolare si adegua con naturalezza alla complessità interiore dei due amanti, riflettendo in particolare l’incessante bisogno di Francesco di esibire le proprie qualità letterarie. Le sue lettere si trasformano spesso in un palcoscenico su cui mettere alla prova il proprio stile, intriso di suggestioni letterarie del primo Novecento, dove echeggiano la solennità di Carducci e la languidezza poetica di d’Annunzio, in un linguaggio che si muove tra il rigore classico e l’enfasi melodrammatica(6). Francesco attinge ai suoi ricordi scolastici, cita letture, ma soprattutto costruisce pensieri illustrati, alle volte forzati nella loro tensione emotiva, malinconici, altre volte ricchi di metafore un po’ barocche: il «raggio di sole tiepido» che filtra dalla finestra della «stanza solitaria», per riscaldare i «cuori palpitanti all’unisono» (ivi, pp. 34; 61); il dolore evocato dall’idea di un amore «calpestato» (ivi, pp. 39; 76); oppure, con un’intensità quasi teatrale, la fantasia di penetrare furtivamente nella stanza di Stamura per spiarla, afferrarla e amarla (ivi, pp. 36). La scrittura di Francesco è infatti caratterizzata da una forte carica espressiva: aggettivazioni enfatiche, sostantivi potenziati da attributi di grande intensità, impiego di forestierismi di ambito militare (es. edelweiss, shrapnel), ripetizioni per epanalessi, sinestesie e un uso insistito di similitudini. Numerosi sono gli esempi che potrebbero essere citati: «flessuosa personcina» (ivi, p. 62), «il cuore mi batte forte forte, mi tremano le gambe» (ivi, p. 36), «le tue parole, come la punta di un coltello, mi sono penetrate nel cuore» (ivi, pp. 39; 75); «L’espressione del tuo amore assume nella mia fantasia troppo suscettibile, una misura troppo grande rispetto alla mia, che mi sembra minima…» (ivi, p. 73).
Tuttavia, l’imminenza della guerra introduce un mutamento nel tono delle lettere di Francesco. Con l’avvicinarsi del maggio 1915, il suo linguaggio si fa più essenziale, segnato dall’ansia e dall’incertezza. Giunto a Vittorio Veneto, a trenta chilometri dal confine austriaco, e assegnato al Decimo Gruppo del 13° Artiglieria di campagna, il ragazzo si trova di fronte a un futuro incerto: come molti suoi coetanei, non sa ancora se e quando la guerra diventerà realtà. Nelle sue lettere, condivide con Stamura sensazioni e preoccupazioni, descrive la trincea, i tabià, chiede con insistenza parole d’affetto e notizie del loro «piccino»(7).
Preservando dunque il valore del documento epistolografico, Elvira Buonocore e Anna Rita Vitolo sono riuscite a trasformare una microstoria privata in un esempio di public history, restituendo alla memoria collettiva la voce di due giovani amanti travolti dalla tempesta della Prima guerra mondiale. Come «gocce» di pioggia in un temporale – per usare l’immagine che Ippolito Nievo ci offre nelle Confessioni di un italiano –, Stamura e Francesco sono individui «singoli», eppure parte di un dramma più grande, di un destino che li trascende e li consegna alla Storia. Sono «gocce» di pioggia che danzano nell’eternità, a custodire l’indistruttibilità di un amore autentico e sincero, come nel fluire inarrestabile del tempo di Henri Bergson:
[…] Vedo ancora – nell’album di Gavarni, credo – un disegno rappresentante due monelli che conversano insieme: l’uno, credendo di imbarazzare l’altro: «Che faresti se fosse la fine del mondo, se la terra volasse in pezzi, se fosse la distruzione di tutto, se non ci fosse più nulla, nulla, nulla?» – «Io? Rientrerei in casa». Motto commuovente! Esprime la fede nell’indistruttibilità del focolare domestico, la fiducia del figlio nei propri genitori, che stanno là, che staranno là, qualunche cosa avvenga, ancora se non dovesse rimanere più null’altro che loro(8).
Luca Vaccaro
(Università di Bologna)
- L’evento è stato ideato per la didattica del Laboratorio di Letteratura Teatrale Italiana, A.A.2024/2025 – 27928 LABORATORIO (1) (LM) (G.E) – Università di Bologna (Dipartimento di Filologia classica e Italianistica). Al riguardo, mi permetto di rinviare al contributo di Gius Gargiulo consultabile al link della rubrica “L’altro sguardo”: https://www.centrostuditeatro.it/2024/09/il-fiore-che-ti-mando-lho-baciato-come-laboratorio-di-filologia-commossa-e-di-creativita-rigorosa-alluniversita-di-bologna/
- L’espressione «filologia commossa» è tratta dal titolo dell’introduzione di Luisa Avellini, Nota al testo: una filologia commossa fra le carte di famiglia, al volume Microstoria nella Grande Guerra. Lettere di Ester a Federico 1914-1918, a cura di L. Avellini e F. Tarozzi, Città di Castello, I libri di Emil, 2015; ma si veda anche il contributo di Andrea Battistini, La Lingua di due innamorati in un carteggio della prima guerra mondiale, «Schede Umanistiche», XXX, 2016, pp. 11-27.
- Il fiore, pp. 37; 66: «[…]Tu non devi piangere ma devi essere altera di te e del mio amore, indipendente, senza scrupoli e timori, e sprezzaretutto e tutti».
- Ivi, p. 37: «[…] Io non ti muoverò una parola di rimprovero, ma non devi per nessuna ragione mai farmi passare da stupido. È l’unica cosa a cui tengo nella vita».
- Ivi, p. 63: «[…] se la fantasia mi dipinge che i tuoi occhi si posano su qualche cosa che non è mia, se sospetto che un altro ti guarda, ti giuro, Stamura mia, mi vengono le vertigini dalla gelosia e dal dolore…»; vd. anche pp. 33 e 63.
- Ivi, p. 129: «[…] Oh l’incanto di questi posti per il poeta e l’amante. Aveva ben ragione il Carducci poetando sulle bellezze del Cadore»; ivi, p. 85: «Ma esci, se credi, divertiti, va a teatro ora che si dà qualche opera nuova di D’Annunzio, come Il Ferro».
- Ivi, p. 125: «[…]Fra giorni ti manderò una coccarda tricolore che porto al petto, tu la metterai al petto al piccino e gliela farai portare sempre…».
- H. Bergson, Il significato della guerra, Mimesis («Minima/Volti», 46), Milano-Udine, 2013, pp. 28-29. Al messaggio contenuto in questo brano bergsoniano si accosta particolarmente la chiusa della lunga lettera inviata da Francesco a Stamura il 30 giugno 1915: «[…] Nella mia cassetta che ho qui presso di me sotto la tenda vi è un biglietto chiuso in busta con una ciocca dei miei capelli: sono pel mio piccino, a cui tu li consegnerai quando potrà capire… Digli che quei capelli sono bagnati dal sudore, dai disagi, dalle pene di un uomo nel fare il suo dovere a prò della maggior grandezza d’Italia» (Il fiore, p. 119; 46).