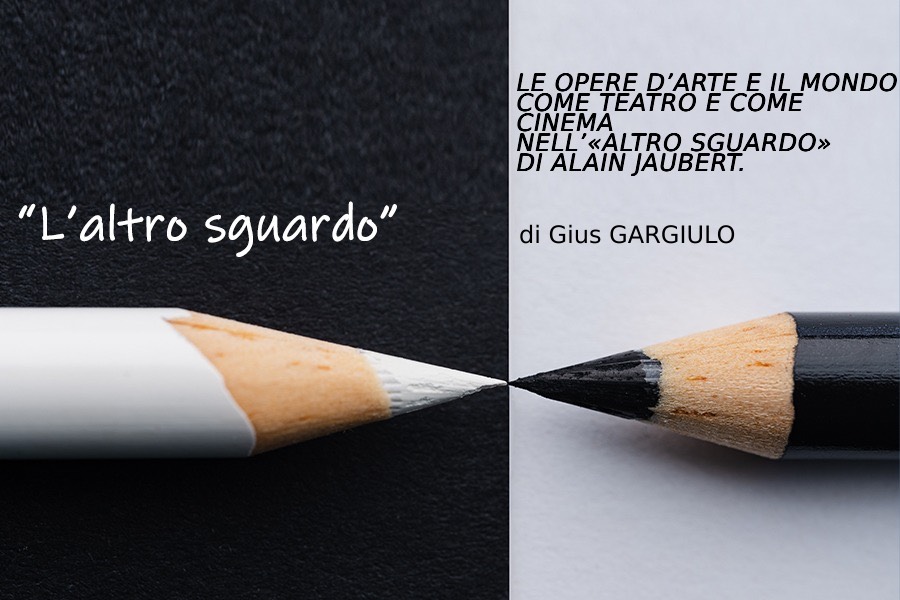E mi dirò “in frammenti”»: la dispersione dell’io. Una riflessione su “Tà-Kài-tà” di Moscato e su Pessoa
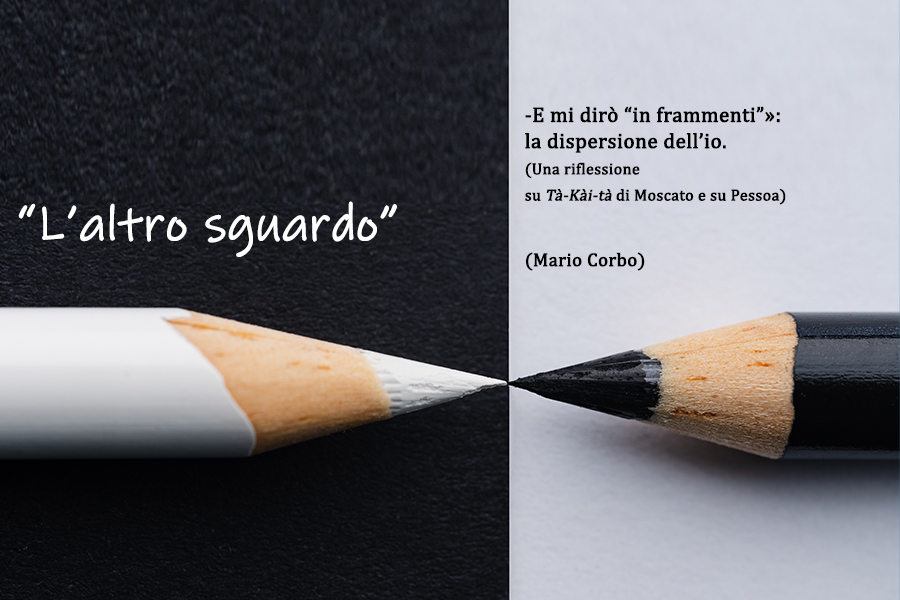
L’ALTRO SGUARDO
Enzo Moscato, Tà-kài-Tà (Eduardo per Eduardo), a cura di Antonia Lezza, Spoleto, Editoria & Spettacolo, 2020.
«E mi dirò “in frammenti”»: la dispersione dell’io.
di Mario Corbo
Tà-kài-Tà, il testo di Enzo Moscato, pubblicato nel 2020, nella collana Percorsi, per i tipi di Editoria & Spettacolo, si segnala come una preziosa edizione critica, curata, in modo esemplare, da Antonia Lezza, il cui saggio introduttivo offre al lettore la chiave ermeneutica per comprendere il senso dell’opera e, nello stesso tempo, costituisce, data l’ampiezza delle tematiche affrontate, una ‘prefazione’ chiara ed esaustiva al teatro di Enzo Moscato, nel suo complesso, tesa ad esplicare i fondamentali nodi concettuali di un percorso articolato e ancora in fieri. Pertanto, a tale saggio si rinvia per quanto concerne l’esegesi testuale dell’opera, nei suoi aspetti teoretici, simbolici e polisemici e nei rapporti intertestuali con le tematiche generali della ricerca drammaturgica dell’autore. In queste brevi note si cercherà di cogliere qualche ‘suggestione’, che mi pare emerga dalla lettura di un testo raffinato ed evocativo, qual è appunto Tà-kài-Tà, composto da un autore, filosofo e poeta, oltre che attore e regista, che non ama celare le proprie letture, ma raccontarle quali inestinguibili fonti ispiratrici delle sue opere.
L’antica concezione del tempo, di matrice ellenica, riteneva che tutto ritorna e nulla vada perduto: allo stesso modo nell’esperienza teatrale di Enzo Moscato, che, nel procedere oltre, volge lo sguardo all’indietro, nell’immaginare il novus, ritrova l’antico, secondo un movimento spazio-temporale peculiare del suo teatro: realtà labirintica, fingimento, trasfigurazione del reale e non suo mero rispecchiamento. Pertanto, ‘tutto è in tutto’- l’antico motto anassagoreo – è più che mai vivo nella ricerca attuale di Moscato, che, col passare degli anni, appare sempre più ricca e composita, moltiplicando gli intrecci con le esperienze drammaturgiche trascorse – sia proprie che altrui – riproposte in forme e contesti inediti, frutto di una profonda esperienza scenica e di nuove contaminazioni culturali. Tale processo, evidente in Tà-kài-Tà,senz’altro aumenta il fascino che promana dai testi di Moscato, ma ne accentua anche la densità argomentativa, ne incrementa la bellezza, ma anche lo spessore teoretico: elementi che, agendo in sinergia, rendono quest’autore unico e immediatamente identificabile nella galassia drammaturgica contemporanea. Nello specifico Tà-kài-Tà incarna, in modo emblematico, il percorso di innesto del nuovo sull’antico, del non detto sul già detto, non in modo meramente autoreferenziale, ma attraverso il confronto inevitabile e talvolta ‘crudele’ con l’immagine del ‘padre’: incontro/scontro che non può essere disatteso o procrastinato sine die, in quanto solo un ‘affrancamento’ dal legame di dipendenza che lega ogni essere umano alla figura paterna può determinare le condizioni per una crescita in piena autonomia.
L’A. affronta, dunque, in questo testo del 2012, la storia e la tematica del rapporto con uno dei ‘padri’ indiscussi della vicenda drammaturgica del Novecento, non solo partenopea, ma nazionale e internazionale: Eduardo De Filippo. Platone, nel Sofista, si poneva l’obiettivo imprescindibile del ‘superamento’ del ‘padre’ Parmenide; difatti, senza un processo di distacco dal grande eleate, la sua riflessione filosofica non si sarebbe evoluta in piena autonomia, seguendo l’inedita rotta imposta da una nuova navigazione, che lo avrebbe condotto verso una delle intuizioni fondamentali della filosofia occidentale: la scoperta del mondo soprasensibile e la nascita della metafisica. Senza la ‘morte’ del padre, senza il ‘parricidio’ perpetrato nei confronti di Parmenide, la filosofia platonica, imbrigliata dalla rigidità degli assunti eleatici, non avrebbe spiccato il volo. Allo stesso modo Moscato affronta il rapporto con Eduardo, a cui il testo in questione è dedicato, mostrando palesemente, sia nel linguaggio che nel pensiero, la sua ‘lontananza’ dai modelli teatrali del Padre/Maestro, che, come è noto, l’A. dichiara di non aver mai incontrato in modo diretto, non avendo mai avuto l’occasione di lavorare con lui. Di conseguenza, lascia intuire la necessità che anche la drammaturgia contemporanea realizzi, alla stregua di Platone, una sorta di ‘seconda navigazione’ (l’intera sua produzione si muove in questa direzione), puntando la prua verso nuovi approdi, che, facendo tesoro di tutto il pregresso (il già editus) si spinga verso il novus (l’ineditus), secondo un movimento dialettico sostanzialmente inclusivo, che procede conservando, tende all’altrove, non gettando a mare la tradizione autentica, che è un valore quando resta tale, ma diventa zavorra, quando si trasforma in convenzione o tradizionalismo.
In Tà-kài-Tà, complessa opera della maturità, emerge con chiarezza il modo con cui il nostro A. ‘vede’ e ‘sente’ il teatro e, quindi, in essa è possibile scorgere alcune ‘suggestioni’ poetiche, in parte implicite, in parte chiaramente espresse, sottese a tale ‘visione’.
Nella prima, articolata didascalia (pp. 34-35) l’A. descrive gli oggetti presenti sul palco, scarni e irrelati in un’inquietante fissità: una cassapanca, una sedia e un leggio di legno, «solitario e allampanato, come una triste gru su una zampa sola», scrive poeticamente Moscato. Sul palcoscenico inoltre, disposte simmetricamente, pendono dall’alto bande di stoffa bianca lucida e quasi sfavillante, in grado di riflettere le immagini proiettate su di esse durante la rappresentazione.
La sala è ancora immersa nell’ombra, quando compare, indistinta, una Figuretta scenica (Corp’Anima E) che si aggira tra i palchetti nella zona alta della platea, spaesata, come se si fosse persa in una sorta di labirinto. Durante la rappresentazione immagini intere o parziali di tale Figuretta/Personaggio/Corp’Anima E saranno proiettate sulle bande di stoffa bianca, in modo da essere visibili e «baluginanti». Dopo l’accurata descrizione della scena, l’A. rivela la ‘poetica’ ad essa sottesa, fornendo alcuni elementi utili per arricchire la tradizionale ermeneutica del testo.
Le baluginanti apparizioni della Figuretta scenica nella parte più suggestiva della scenografia servono, afferma Moscato, “non tanto, forse, per esaltare narcisisticamente la fisionomia dell’Ego Narrans, quanto piuttosto per «affollare la sua assoluta solitudine», o, sempre per citare l’immenso Pessoa, per «moltiplicarla e così condividerla – ostia comune – con i resti, altrettanto desolati, dell’Universo-Mondo”.
Mi pare illuminante la citazione di Pessoa da parte di Moscato, posta non a caso nella didascalia di esordio, in quanto fornisce al lettore la bussola per orientarsi nella realtà ’labirintica’ e ‘finzionale’, qual è il teatro, nel modo da lui inteso e vissuto. Nel Novecento probabilmente nessuno più di F. Pessoa ha intuito ed espresso, in modo liricamente paradigmatico, l’intuizione di un io disperso e frantumato, attraverso l’inventio di una pluralità di eteronimi dialetticamente correlati tra di loro a lui-stesso, all’ortonimo Fernando Pessoa.
Come ha mostrato il grande poeta portoghese, con il suo plurimo mondo poetico orto-eteronimico, l’autentica comprensione dell’essenza umana richiede la rinuncia all’immagine di un ‘soggetto’ serrato nei limiti angusti di un’identità statica ed univoca. Il nostro io è un io plurale, che si costruisce dinamicamente nel rapporto con gli altri, tramite il valore della differenza. I contenuti provenienti dall’alterità, in simbiosi con i dati della propria storia genetica e culturale, danno vita ad un’identità, ‘fluida’ e ‘liquida’, come la società in cui ci troviamo a vivere attualmente.
Sensibile a tale visione poetico-antropologica, Moscato afferma, attraverso parole pronunciate da E.2, il ‘doppio’ di Eduardo che parla di sé stesso: «E mi dirò per frammenti […] io sono vivo, e l’unica condizione che pongo per continuare ad esserlo, è il frammento, la-di me-scomposizione […] E, i sensi, vuie ‘o vedìte, tutti ‘e cinque, so’ divisi, ognuno sta p’ ‘e fatte suòie, insieme all’organica funzione che gli è propria. / In un certo senso, pure loro song’ anarchici frammenti, e, per scherzo, sulo per “vulìo”, per trarvi in un tranello, fanno mostra di essere un “insieme” […] un insieme ordinato, coerente, logico, che non si contraddice o si smentisce mai, un insieme che tutti possono sapere a pappardella – tanto è convenzionale, e banale, e riduttivo […]» (pp. 71-72).
Mi pare evidente come Moscato/Eduardo sia cosciente della struttura plurima e anarchica dell’io e della necessità di sentirsi plurali come l’universo, alla stregua di Pessoa, che liricamente afferma: «Mi sento multiplo. Sono come una stanza con / innumerevoli specchi fantastici che deformano / in riflessi falsi una unica anteriore realtà / che non è in nessuna ed è tutte» (F. Pessoa, Il mondo che non vedo, Milano 2015, p. III).
Egli ritiene che l’insieme coerente e logico, nel quale l’identità del soggetto tende a rappresentarsi e ad essere percepita dall’esterno, sia solo un ‘dato fenomenico’ a cui è sottesa – si potrebbe dire – una ‘realtà noumenica’ costituita da elementi plurimi e ‘frammenti’ talora divergenti, in tensione verso un’armonia mai raggiungibile in modo definitivo, alla stregua di Pessoa, che così si esprime: «Lascio al cieco e al sordo / l’animo con frontiere, / ché io voglio sentir tutto / in tutte le maniere. / E siccome sono frantumi / dell’essere, le cose disperse, / spezzo l’anima in frammenti / e in persone diverse» (F. Pessoa, Il mondo che non vedo, cit., p. XIII).
Pertanto, senza generalizzare, ma limitandoci a considerare Tà-kài-Tà, mi sembra chiaro che Moscato avverta tutto il fascino della poetica pessoana, sia nel modo in cui è definito il teatro, sia nella descrizione del Personaggio/Eduardo, presentato sempre come un ‘io plurale’: dalle immagini baluginanti e molteplici della Figuretta scenica, spaesata come in un labirinto, all’io corale, costituito della folta schiera di Fantasmi e giovani Spiriti, che discettano sull’essere e il dover essere del teatro, fino alla scissione nel ‘doppio’ rappresentata da E.1 ed E.2, che, in realtà, attraverso un gioco di specchi e di rifrazioni include anche lo stesso autore che, confrontandosi, col padre, si confronta con sé stesso. Anche se questo è vero, Eduardo (E.1), parlando di sé stesso, ammette, comunque, di non essere mai riuscito a conoscersi fino in fondo, nel suo essere plurale: «Gran parte di me stesso è stata estranea, ignota, a quella che era certa di sapere. / E siamo andati avanti in questo modo, pe na vita intera, io e l’ignoranza di altri “io” – che pure erano in me – come inquilini strampalati dello stesso “luogo ‘e casa”» (p. 73).
Prendiamo ora in considerazione la Premessa, firmata dall’autore.
Pur non mancando in Tà-kài-Tà chiari e concreti riferimenti biografici alla vita e all’opera di Eduardo, in essa si afferma: «Tà-kài-Tà non si basa su nessun dato biografico scientifico o certo intorno alla vita, interiore ed esteriore, di Eduardo De Filippo. È un periplo immaginario, fantastico (e quello della fantasia è l’unico dono “vero”, forse, che un drammaturgo, un giocatore/fingitore di vita e di idee, può dare ad un altro drammaturgo, a un altro giocatore/fingitore di vita e di idee), intorno ai pensieri e ai sentimenti, ante e post mortem, che possono avergli toccato, per un attimo, l’anima e il cuore» (p. 29).
Anche questo passaggio mi sembra rivelativo della comune sensibilità che lega Moscato a Pessoa, che, nella poesia ortonima più celebre, l’Autopsicografia, scrive: «Il poeta è un fingitore. / Finge così completamente / che giunge a fingere che è dolore / il dolore che davvero sente» (F. Pessoa, Il mondo che non vedo, cit., p. XXIII). Pessoana, in una certa misura, è la definizione del drammaturgo come “fingitore”, proposta da Moscato, e, di conseguenza, l’idea del teatro come ‘realtà finzionale’, “un procedere per ipotesi, illazioni, supposizioni, né malevoli né benigne, solo spontanee, irriflesse, istintive (p. 29). E più avanti ancora: «Il teatro muore quado si limita a raccontare i fatti» o «solo le conseguenze dei fatti accaduti» (p. 48). E poi: «a teatro, la suprema verità è stata, e sarà sempre, la suprema finzione» (p. 57); «Il teatro nasce dal teatro. Puoi fare teatro… solo se sei tu teatro» (p. 63).
L’esperienza teatrale così intesa non può non essere ‘attraente’, provocando nello spettatore la fondamentale emozione della ‘meraviglia’, che Aristotele addirittura poneva a fondamento del sorgere dell’attività filosofica. Qualora il teatro smettesse di produrre ‘meraviglia’, in tutte le sue declinazioni, nell’animo di chi lo fa e di chi lo fruisce, cesserebbe di essere tale: cioè, luogo in cui ‘perdersi’ nel mare delle emozioni, come in una sorta di labirinto borgesiano.
Come Pessoa, di certo anche Borges, con la sua idea di labirinto, luogo ‘magico’ in cui smarrirsi per poi ritrovarsi, suscitando stupore e meraviglia, non è estranea all’animo sensibile di Moscato che si confronta – grato e discreto – con i grandi del pensiero e della letteratura, metabolizzandoli e dando vita ad opere di indubbia originalità, come nello specifico Tà-kài-Tà, in un panorama teatrale, invece, spesso omologato e carente proprio sotto il profilo dell’unicità e della riconoscibilità.
Mario Corbo