Guida Galattica per i Lettori | Settembre 2024

- AMICO ROMANZO Amar. Una favola laica di Sara CARBONE
- SIPARI APERTI Galassia Eduardo: le origini di un teatro e le sue reinvenzioni di Annamaria FERRENTINO
- COME SUGHERI SULL’ACQUA Il cielo è un abisso di stelle di Ariele D’AMBROSIO
AMICO ROMANZO
AMAR. UNA FAVOLA LAICA
di Sara CARBONE
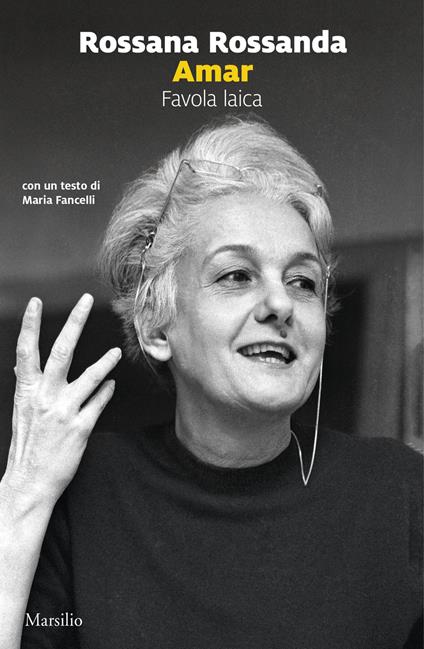
Quando si vive più del tempo dovuto, è come se si vivesse «abusivamente», come se si diventasse mortali «a termini prolungati, a scadenza illimitata, parassiti della vita altrui» sostiene Rossana Rossanda in Amar, una «favola immaginifica e politica» riproposta, quest’anno, dalla casa editrice Marsilio e pubblicata, per la prima volta, nel 1996, in La vita breve. Morte resurrezione, immortalità. Considerato un unicum nella produzione dell’autrice per stile narrativo e contenuto, il racconto in cui la Rossanda «tesse il dolce canto dei nostri limiti», è la storia di un medico, Amar, il quale ha chiesto e ottenuto da Dio l’immortalità, quasi come ricompensa per il dolore dei tanti lutti familiari subiti.
Presentato in media re, il protagonista sta per compiere trentacinque anni, ha già perso entrambi i genitori e ha imparato che, nella vita, «non sempre si guarisce, e una volta si muore». Dopo la morte dei suoi figli, Amar viene convocato da Dio, assieme alla moglie Sita: qualunque desiderio essi esprimano, sarà esaudito. L’uomo chiede l’immortalità mentre sua moglie la rifiuta perché le è stato tolto troppo e preferisce andare, giorno per giorno, incontro alla fine. Così, Amar, da buon medico, dedica la sua vita a «dilatare» quella degli altri e scongiurare, più che la morte della moglie, «il suo scomporsi» come corpo. Quando Sita muore, Amar si sente, per la prima volta, senza Dio e senza il mondo e comincia a maturare «la noia profonda del non finire», dissimulando tale presa di coscienza per non mostrarsi debole davanti a quel Dio che ha sospeso la sua condizione di mortale.
Le riflessioni sulla finitezza della vita umana, che la Rossanda colloca fuori dal racconto in una introduzione a parte, potrebbero idealmente inserirsi proprio in questo punto della narrazione ed essere la naturale prosecuzione delle convinzioni che Amar matura e «che era meglio non frequentare», cioè che «l’essere eternamente doveva somigliare al non essere affatto». Giunta alla composizione di tale «favola laica» dopo la predita di due persone care – la figlia di un’amica, una ragazza di «un’arrogante bellezza», e un medico -, la fondatrice de «il Manifesto» ci conduce nel cuore delle riflessioni di un’intelligenza laica sulla vita umana e sul senso stesso della scrittura. Senza la sua finitezza, l’uomo evidentemente non sarebbe capace di conoscere e, soprattutto, di amare; se non morisse, egli non coglierebbe il senso autentico della vita che gli è tanto cara perché la materia di cui questa è fatta è proprio il tempo che fugge. La scrittura, dal canto suo, rappresenta, prima di tutto, un «rifugio nei territori dell’infanzia», perché da bambini la morte «non la si intende»; è, poi, espressione di un disagio quando, in età matura, si è assistito alle «morti massicce» provocate dalle guerre che lasciano nell’uomo un desiderio di guarigione e palingenesi più che di pianto. Infine, la scrittura – come la Rossanda afferma già nell’articolo Autodifesa di un io politico del 1979 – è accolta, quando si è vecchi e la morte è diventata metro per misurare tutte le «attese dell’arco della vita che è stato nostro», come «un placarsi che nell’essere e nel fare non è dato».
E la scrittura di questa dirigente del PCI, radiata perché dissidente, è tutte queste cose insieme quando, nel 1992, si trova in un monastero benedettino a Monte Giove, vicino Fano, e viene individuata come una dei due coordinatori del seminario dal doppio tema: Morte: paura e dolore; Morte, resurrezione e immortalità. Affiancata, nel compito, dall’intellettuale cattolico Filippo Gentiloni, il quale paradossalmente conclude che «anche la morte è un atto politico», quest’autrice militante «senza cariche e senza partito» arriva alla stesura di Amar raggiungendo punte di quell’elevatissima spiritualità, di quell’intimo e profondo misticismo di cui sono evidentemente capaci certi spiriti laici, persuasi del fatto che «il sapore del vivere» è dato dal morire e che a nessuno, come avrebbe detto Gabriel García Marquez, è riservata una seconda opportunità sulla Terra.
È una “una prosa in versi” la storia di Amar che, da umano senza tempo, “si tuffa” continuamente in epoche future: ora affondando la sua barca in mare, raggiungendo a nuoto la nuova era e portando in salvo «le carte essenziali ben protette in più pelli di pecora»; ora introducendosi, come «un filo in una trama che si stava tessendo», nelle «epoche in cui tutti parevano dover nascere e morire visibilmente in una rete di informazioni»; si difende dalle emozioni troppo forti sapendole transitorie; evita le guerre e, solo quando muore sua moglie, sebbene sia diventato più saggio, più sobrio e più parsimonioso di sé, si accorge che nessuno più, dopo Sita, mostra interesse a sapere chi lui sia e da dove venga. Il suo corpo è sempre di più «fuori dalle regole» ma soprattutto – e questo assume tutto il sapore di un’amara riflessione da parte dell’autrice -, «gli uomini […] nella fretta perdono tutto o gran parte del passato di cui restano pochi brandelli che non interrogano» e Amar, in quanto creatura “durevole”, è un brandello di passato che non suscita più attenzione negli altri che vivono il presente. Il gioco di Amar con il tempo, la superbia dell’uomo di potergli resistere è, in parte, scritta nel suo stesso nome che potrebbe essere, secondo Maria Fancelli, autrice della postfazione, l’anagramma di Mara, il nome della mamma della giovane amica morta, piuttosto che un tributo al personaggio di Amar del romanzo Il contesto. Una parodia di Leonardo Sciascia.
Mentre Amar, quasi descritto con quel realismo magico dei personaggi di Cent’anni di solitudine, è figura dinamica, che attraversa i secoli, accumula conoscenza e perde via via le domande, Sita è donna saggia è ab origine; conosce le insidie del tempo e della malattia, non vuole vivere circa 122 anni come la Ursula di Marquez, ma desidera andarsene parlando e sentendo la sua mano in quella del marito, «senza troppa devastazione» del corpo. La scrittura della Rossanda è, del resto, pervasa di ombre femminili, vero motore della storia di Amar così come della vita umana: se la morte di Sita – incarnazione dell’amore e del sentimento – è utile al protagonista per comprendere che non ha senso vivere mentre gli altri se ne vanno, è la donna che gli appare alla fine – incarnazione stavolta del pensiero e della ragione – a obbligarlo alla consapevolezza, alla presa di coscienza e a indurlo a chiudere il suo conto aperto con Dio. Sita gli ha chiesto di tenere la mano nella sua; questa gli pone, invece, la domanda tipica «degli amanti inquieti»: – Che pensi? E quando lui realizza che è ora di andare perché con la sua immortalità ha perduto tutti ma nessuno ha perduto lui, in una prospettiva rovesciata, chiede alla donna di aiutarlo a morire, afferrandosi alla sua mano.
Di Amar, come di tutti gli uomini della Letteratura e della realtà che hanno sfidato la finitezza del tempo, pensando di potergli dare scacco, non resta altro che «il peso delle parole non dette, il muro che [egli ha] messo fra sé e gli altri».
Sara Carbone
SIPARI APERTI
GALASSIA EDUARDO: LE ORIGINI DEL TEATRO E LE SUE REINVENZIONI
di Annamaria FERRENTINO

La studiosa Anne Ubersfeld, in un testo diventato uno dei fondamenti degli studi teatrali, “Lire le théâtre” (pubblicato nel 1977 per Éditions sociales) parla del testo drammaturgico come texte troué, ovvero bucherellato. Con questa definizione, fa riferimento alla connaturata incompiutezza di tale tipologia testuale, la quale necessita che alla scrittura dell’autore se ne aggiungano altre, ad ogni messa in scena: quella del regista, degli attori, dello scenografo. La sovrapposizione di scritture, o la continua riscrittura, fa parte del processo creativo stesso di un’opera teatrale, la quale muta senza raggiungere una forma definitiva. Ci sono casi, però, in cui una forma resta particolarmente scolpita nella memoria del pubblico e della critica e difficilmente riesce ad essere reinventata. Questo è certamente il caso del teatro di Eduardo.
Se le edizioni televisive delle commedie (in particolar modo, i quattro cicli de “Il Teatro di Eduardo”, dal 1962 al 1981), ne hanno immortalato la fisionomia, la voce, la prossemica e, non ultimo, il ruolo di capocomico, decisivo è stato il coinvolgimento totale di Eduardo nella creazione dell’opera, da autore, regista, attore e direttore di teatro, per cui risulta arduo scindere Eduardo dalle sue opere e viceversa. Per questo motivo, una sorta di paradosso riguarda la sua produzione. Da un lato ha senza dubbio quelle caratteristiche che permettono di annoverarla tra i classici, ovvero le opere che richiedono di rivivere, di essere messe in scena ancora, perché, riprendendo- non senza qualche rischio – la definizione icastica di Calvino, non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Dall’altro essa genera un particolare timore negli attori o nei registi che desiderano riportarla in scena e il confronto con Eduardo diventa inevitabile (almeno nei confini nazionali e regionali), in alcuni casi spietato. In quali modi è possibile riscrivere e proporre un autore come Eduardo? O meglio, quanti e quali sono i modi che le opere stesse, in quanto classiche, ci suggeriscono?
Il volume di Célia Bussi, dottoressa in studi teatrali alla Sorbonne Université di Parigi, pone al centro proprio quella che potremmo definire “Galassia Eduardo”, partendo dalla sua fisionomia fino ad arrivare alle sue riscritture. Alla base dello studio, intitolato “Eduardo De Filippo. Fabrique d’un théâtre en éternel renouveau” e pubblicato dalla Sorbonne Université Presses nel 2021, risiede un’attenta e nutrita ricerca che non vuole limitarsi ai testi drammaturgici. L’obiettivo è la lettura e la ricostruzione della scena nella totalità dei suoi codici espressivi, aspetto inevitabile, se si considerano i ruoli che Eduardo ha ricoperto nella macchina teatrale. Le fonti primarie, dunque, raggiungono dimensioni monumentali: più di cinquanta copioni, quaranta interviste realizzate, tra interpreti, registi e collaboratori (tra cui ricordiamo Regina Bianchi, Isa Danieli, Carlo Giuffrè, Gigio Morra, Cesare Accetta, Carlo Cecchi, ma anche Hervé Pierre, Anne Coutureau, Jacques Nichet), settantacinque fotografie di scena, sessanta registrazioni di spettacoli. L’autrice specifica nell’introduzione che, in ragione della priorità data alla dimensione scenica, ha privilegiato il processo creativo che non si arresta alla redazione del testo, ma che si nutre delle prove, della creatività degli attori e della cooperazione con le altre figure artistiche e che lascia una traccia tangibile nei copioni (del regista o del suggeritore, durante le prove), conservati alla Biblioteca del Burcardo di Roma e al Gabinetto Vieusseux di Firenze. Per questo motivo nel volume viene dato ampio spazio all’analisi delle didascalie, che ne rappresentano il fil rouge. La struttura, infatti, è bipartita: la prima sezione, intitolata “Eduardo De Filippo, un artiste aux multiples talents” è dedicata interamente alla costruzione del teatro dell’autore- volendo riprendere il titolo del volume che fa riferimento proprio al processo di “fabbricazione”- e si suddivide ulteriormente in quattro capitoli, consacrati rispettivamente alle sue funzioni, di autore, regista, attore e direttore di teatro. Le didascalie sono la traccia evidente della cooperazione tra tali funzioni: nella prima proposta autoriale interviene l’indicazione registica, la gestualità dell’attore, l’esigenza pragmatica del direttore. L’autrice segue l’evoluzione di tale traccia, partendo dai manoscritti e senza mai tralasciare le varie edizioni, quella a cura di Anna Barsotti per Einaudi (1995-1998) e quella di Nicola de Blasi e Paola Quarenghi per la collana de “I Meridiani” (2000-2005) e, non ultime, le fortunate versioni televisive.
La seconda sezione del volume, “L’oeuvre d’Eduardo De Filippo revisitée” analizza alcune delle rivisitazioni della produzione dell’autore, focalizzandosi in particolare sulla tipologia delle modalità di messa in scena a partire dagli originali. Qui il concetto di autorialità viene arricchito e ampliato. Come una creazione registica e attoriale può sovrapporsi, o quanto meno porsi, in rapporto alle opere eduardiane? Ancora una volta, la didascalia ha un ruolo fondamentale, essendo il primo elemento di intervento individuato dalla studiosa, fino ad arrivare alla modifica del testo drammaturgico (tagli, aggiunte, spostamenti di sezioni), all’introduzione o eliminazione di personaggi, al richiamo intertestuale o alle modifiche del ritmo. Nella messa in scena di Homme et galant homme proposta da Felix Prader (1991), ad esempio, viene sviluppata e rielaborata l’immagine del nano nel secondo atto, quando Gennaro, dopo che Assunta ha rovinato la sua giacca, bruciandola, le dice: “Un nano ti devi sposare. Un nano, cu na capa tanta…”. Eduardo, inserisce questa gag in un secondo momento, dopo l’elaborazione del testo e durante le repliche. Il regista francese non solo la ripropone successivamente, ma in qualche modo la anticipa, quando durante il loro primo incontro, Gennaro le augura di trovare, al contrario, un principe, per ringraziarla per l’aiuto offerto. La sovrapposizione di queste due immagini fa sì che Assunta possa incolparlo per aver creato in lei una certa confusione: “Avec vos histoires, vous m’avez fait rêver!”. Prader con l’aggiunta di questa battuta e dell’immagine del principe, traduce l’atmosfera di follia che regna alla fine del secondo e del terzo atto.
L’autrice sottolinea che la riscrittura di un’opera coinvolge tutti i suoi codici espressivi. Nel volume sono analizzati esempi in cui l’utilizzo della musica accentua i risvolti tragici o comici- per lo più compresenti negli originali- di un personaggio o di un epilogo (Oswald d’Andréa, compositore dello spettacolo “Sik-Sik, le maître de magie/ Le Haut-de-forme, diretto da Jacques Nichet nel 1991, si rifà a Fellini per rappresentare una doppia natura di Sik-Sik); o ancora, in cui gli attori propongono, di volta in volta, interpretazioni diverse di uno stesso personaggio (il riso di Silvio Orlando nell’epilogo di Questi fantasmi!, diretto nel 2004 da Armando Pugliese, che ne rafforza l’ambiguità, o la gravità del Peppino Priore di Toni Servillo in Sabato, domenica e lunedì del 2002, che contrasta con l’euforia circostante) .
Dal punto di vista metodologico, uno degli aspetti estremamente interessanti è il criterio della selezione del corpus scelto dalla Bussi. Se da un lato, la studiosa francese è stata influenzata dal fatto che sulle trentanove commedie pubblicate nella “Cantata dei giorni pari” e nella “Cantata dei giorni dispari”, soltanto un terzo circa è stato tradotto, dall’altro, motivando in questo modo l’impianto del volume, sceglie dei testi che negli anni sono stati messi in scena da Eduardo, da un regista italiano e da uno francese. Tale scelta elude qualsiasi rischio di dispersività, che potrebbe facilmente essere causata da un’abbondanza di esempi o di trame, e permette al lettore di seguire attentamente il processo di creazione che riguarda un’opera dalla sua prima stesura e messa in scena fino alle riletture temporalmente successive. Tali opere sono: Uomo e galantuomo, Sik-Sik, l’artefice magico, Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria!, Questi fantasmi!, Filumena Marturano, La grande magia, Le voci di dentro, Bene mio, core mio, Dolore sotto chiave, Sabato, domenica e lunedì, Il sindaco del Rione Sanità, L’arte della commedia, Il cilindro, e Il contratto.
Una particolare rilevanza viene data all’analisi della dialettica realtà-illusione, l’illusione teatrale nello specifico, presente in maniera più o meno massiccia in tutto il corpus e alle sue possibili declinazioni. Ne è un esempio illustre la messa in scena de La grande magia del 1985 diretta da Giorgio Strehler, che invita lo spettatore a soffermarsi su tale aspetto grazie all’utilizzo di una luce di colore blu, che ritorna in più momenti della pièce e che introduce una dimensione soprannaturale quando Marta, moglie di Calogero, approfitta dello spettacolo di Otto Marvuglia per fuggire con il suo amante via mare. La didascalia di Strehler recita: “Di colpo si fa luce blu, cielo blu e il motoscafo di cartapesta scoppietta e manda finto fumo”. Al blu della chimera e dell’illusione si alterna l’irruzione dell’ineluttabile realtà contro cui la magia non ha poteri, tramite una luce rossa, riproposta quando il mago spiega il trucco del canarino in gabbia, che schiacciato, muore. Alla fine, quando Calogero decide di non aprire la scatola, in cui si suppone sia richiusa sua moglie, la luce è violacea, a metà tra il rosso e il blu, proprio perché- dice Célia Bussi- l’illusione in cui ha deciso di restare è divenuta ormai la sua realtà.
Tra le altre messe in scena del corpus eduardiano segnalate dall’autrice, ricordiamo, tra quelle elaborate in Italia: Questi fantasmi! con la regia di Armando Pugliese (2004) e con protagonista Silvio Orlando; Sabato, domenica e lunedì, diretto e interpretato da Toni Servillo (2002); Ha da passà ’a nuttata di Leo De Berardinis (1989), esempio di riscrittura con la giustapposizione di scene tratte da diverse opere di Eduardo e con un meraviglioso Antonio Neiwiller nel ruolo di Concetta in Natale in casa Cupiello; ancora, Le voci di dentro di Alfonso Santagata (2004). Dal lato francese, invece, oggetto dell’analisi sono, ad esempio: Naples millionaire! di Anne Coutureau (2012), Homme et galant homme di Félix Prader (1991), La Grande Magie di Dan Jemmett (2009).
Célia Bussi non tralascia l’aneddotica, proveniente per lo più dalle testimonianze raccolte sotto forma di intervista, come nel caso di Cesare Accetta che racconta di una volta in cui una regista norvegese, desiderosa di mettere in scena Sabato, domenica e lunedì, fu invitata da Eduardo a mangiare il ragù a casa sua, per illustrarle la dimensione rituale di un elemento non secondario della commedia. L’analisi dell’autrice riesce, dunque, a mescolare questo aspetto ad un forte rigore scientifico, con un apparato bibliografico molto nutrito e ben articolato. Il suo punto di forza è la capacità di considerare le opere di Eduardo sia in termini filologicamente fedeli alla poetica dell’autore che nelle sue più audaci reinvenzioni. Se, infatti, l’incipit del volume è canonicamente incentrato sull’autore, soprattutto in quanto figlio d’arte e artista poliedrico, l’epilogo riporta e analizza alcune delle tavole della raccolta di fumetti in tre volumi diretta da Domenico Maria Corrado: “Eduardo-Il teatro a fumetti” (1998-2002). Sia in ambito intermediale, sia in una dimensione internazionale o, più in generale, in una rilettura, il volume della Bussi ci ricorda che Eduardo e con lui la sua produzione, non ha ancora smesso di dirci quello che ha da dire. Come scrive Hervé Pierre, membro della compagnia della Comédie-Française, nell’introduzione del volume: “Le théâtre d’Eduardo c’est l’humanité qui se cherche”.
COME SUGHERI SULL’ACQUA
IL CIELO È UN ABISSO DI STELLE
di Ariele D’AMBROSIO
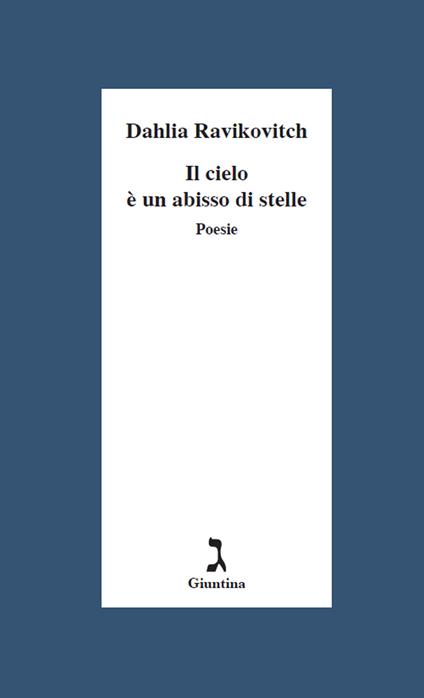
Il cielo è un abisso di stelle
Giuntina, 2023, Firenze
pagine 272
euro 18,00
https://it.wikipedia.org/wiki/Dahlia_Ravikovitch
Il cielo è un abisso di stelle
È da questo titolo che voglio cominciare, un ossimoro concettuale, che ci lascia sospesi perché le stelle che illuminano il cielo di notte diventano, malgrado il loro brillore, un abisso che si è sempre immaginato buio, oscuro, senza alcuna luce. Ed allora mi chiedo: non è che la poesia ci sprofonda nell’abisso dell’oscurità malgrado la luce delle sue parole? E sono luce le sue parole? Quando sono luce? Ma ne parleremo, per definire anche questa “verità” della poesia.
Un libro affascinante questo, la prima antologia italiana dell’opera di Dahlia Ravikovitch, poeta donna israeliana ed ebrea. Ma credo né ebrea né israeliana, perché la sua poetica la fa internazionale e precorritrice di tempi. Dalla sua finestra d’osservazione il mondo, e ci pare che parli anche dell’ora, il tempo che si può dire del sempre: della vita e della morte, dell’umano e della guerra, dell’amore e della donna, del maschio e del figlio. Un percorso di anni e di vita, che raccoglie nei titoli dei suoi otto libri settanta poesie: da L’amore di una mela d’oro del ’59, da Un universo difficile del ’64, da Il terzo libro del ’69, da Abisso chiama del ’76, da Amore vero dell’86, da Mamma con bambino del ’92, da Nuove poesie del ’95, da Grandi acque, del 2006.
Alla fine della lettura mi sono sentito pieno, ed ho cercato i confini di un dettaglio: una copertina dalla cornice rettangolare spessa e blu che contiene un altro rettangolo bianco per il titolo, il nome e l’edizione. All’interno altri rettangoli: le poesie. Tutto a cura di Sara Ferrari per la sua ottima introduzione, traduzione di Suzy Shammah e Sara Ferrari, nota biografica di Bianca Ambrosio e Adam Koman.
L’introduzione è persino necessaria per chi non conosce la storia e la lingua ebraica. Nel libro sempre il testo originale a fronte, ma sulla pagina pari di destra, la traduzione su quella dispari di sinistra, e tale disposizione è perché l’ebraico si legge da destra verso sinistra, come le lingue arabe. Potrebbe essere questo un punto d’incontro? Un dato linguistico che fa per questi popoli il luogo principe per un avvicinamento comunicativo? Dicevo necessaria l’introduzione, perché oltre a comprendere meglio certi specifici della poetica di Dahlia Ravikovitch, si apprende del percorso storico di quegli anni per quanto riguarda il cammino intellettuale in Israele fondato come stato, e dei poeti che prima l’hanno supportato ed altri poi anche criticato. Cosa scriverebbe oggi Dahlia Ravikovitch? Cosa della guerra israelo-palestinese, cosa dell’esercito terrorizzante e del terrorismo militarizzato? Dove le differenze? Nella violenza? Nell’organizzazione? Nella proporzione? Nel diritto? Deciso da chi? Imposto da chi? Dall’orrore della shoah che ora rischia persino di essere dimenticata? Dall’orrore di una devastazione senza fine?
Non nascondo che quando ho letto di questo libro, subito l’ho desiderato per potere toccare con mano cosa un poeta israeliano potesse scrivere di questi misfatti. Ed ho trovato tanto, espresso con una forza emotiva e di scandaglio umano e storico senza uguali.
Intanto si apprende da Sara Ferrari che il verso più strutturato nelle poesie giovanili si “libera” maggiormente in quelle della maturità. Ho tentato attraverso l’attenzione sui dettagli grafici dell’alfabeto ebraico d’individuare finali in rima e ritmi possibili, quasi fossero i significanti del segno, le strofe mi sono state chiare, classiche di tutte le poesie lineari del mondo. Avrei desiderato ascoltarne il suono per definire emotivamente il loro significante sonoro, sempre più riconoscibile e diretto quando non si comprende il significato delle parole di una lingua a te sconosciuta. Cercherò nel web di colmare questo mio desiderio, e pensando come da sempre che la traduzione di una poesia è una trascrizione per altro strumento.
Non andrò a scrivere seguendo la successione degli anni, ma per i temi multiformi che la Ravikovitch ha trattato, e cominciando subito dal segno, dal suono che la parola poeta definisce in un ruolo. Ed è da chi l’ha preceduta, Lea Goldberg, che avviene, già da allora – cosa che non capita ancora nella nostra provinciale nazione italiana –, lo scontro, la rimozione di una poesia “al femminile”, perché io non sono una fanciulla che scrive rime. Io sono un poeta, aveva dichiarato. E Dahlia, dopo, che imponeva di essere chiamata meshorer che in ebraico vuol dire colui che crea i canti. E se le poete di oggi si dichiarano “al femminile” è bene che si rifacciano a chi le ha precedute, e di gran lunga, per non sprofondare nuovamente in un’autodiscriminazione.
Il padre e la sua morte, il tema con cui inizio, è un lutto impossibile da elaborare, già qui il verismo estremo e che si estende anche negli altri temi, e non c’è mai consolazione, la sparizione è un dato che non lascia traccia. «… Là dove si trova c’è presagio di pericolo / come il giorno in cui camminava per strada e un’auto l’ha investito, / e così l’ho conosciuto e ho messo dei segni per ricordare, / che proprio quest’uomo è stato una volta mio padre. // Lui non mi dice nemmeno una parola d’amore / benché sia stato una volta mio padre / benché io sia stata la sua figlia primogenita. / Non può dirmi nemmeno una parola d’amore.». La morte annichilisce azzerando anche il ricordo, la tenerezza, anch’essa sparita, perché il ricordo è una costruzione del presente che evapora un attimo dopo. Resta soltanto il vuoto, l’oscurità indecifrabile di un abisso di stelle.
L’oscurità, che così bene dice Massimo Cacciari, essere una caratteristica propria della poesia, a differenza della filosofia, che usa un linguaggio argomentativo per riflettere e vedere, è mostrata da essa come radice ultima della parola, sprofondandosi nell’enigma e nell’abisso del comunicare, non informare, ma trasmettere questa abissalità del dire, la sua oscurità che si mostra. L’oscurità di un linguaggio che non ci appartiene, perché noi apparteniamo ad esso, e al suo evento originario.
Il tema ora è quello linguistico, che bene si apprende nell’introduzione. L’uso, il traslare frasi delle sacre scritture per farle diventare versi, e così facendo avvicinarsi a un passato e prendere le distanze da poetiche a lei contemporanee, ma di fatto rinnovandosi in uno stile molto personale, ben decifrabile e riconoscibile. La madre di Dahlia Ravikovitch insegnava e formava educatori in studi ebraici, cosa già singolare a quei tempi per una donna. Scritture sacre dalla Genesi, dai Salmi, dalla Qabbalah, dall’Esodo, dal Deuteronomio, dall’Ecclesiaste, dal Levitico, ed altri. Wlodek Goldkorn parla di un sacro laico femminile. Aggiungo: la capacità di desacralizzare il sacro per trasformarlo in un racconto anche popolarizzato che dice e amplifica emozione ed immagine, e in una narrazione apparentemente semplice che di fatto raggiunge la massima complessità che parla, dice, narra. Quante volte una poesia è preghiera che sussurra, e chiede, e spera, e implora.
Scintille di luce è il titolo e la nota ci dice che si riferisce ad uno dei concetti fondamentali della Qabbalah, secondo cui scintille di luce sono intrappolate nei frammenti di vasi rotti della Creazione. Spesso queste minuscole particelle si ritrovano nei luoghi più oscuri. «… E in questa materia oscura si svela una miniera d’oro / questa materia oscura rivela le sue profondità / c’è un amore delicato tra l’oscurità e l’oro. …». Ed ancora in Incantesimi, c’è il pozzo di Miriam. Secondo la tradizione rabbinica, durante la peregrinazione attraverso il deserto il popolo ebraico fu accompagnato da una roccia da cui sgorgava costantemente un’abbondante riserva d’acqua, il pozzo di Miriam, così chiamato in onore della profetessa omonima, sorella di Mosè. «Oggi sono collina, / domani sono mare. / Tutto il giorno mi aggiro – Oggi sono lumaca / come il pozzo di Miriam, – domani albero / ogni giorno sono una bolla – alto come una palma. / persa nei crepacci. / Ieri ero una nicchia, nella notte ho sognato – Oggi sono una conchiglia. / cavalli rossi – Domani sono domani. / viola e verdi, …», (i versi dopo il trattino sono di fianco).
Certo, se si leggono le sacre scritture ebraiche, la storia delle persecuzioni e dei peregrinaggi, la forza che questi testi sacri hanno dato alla psiche di un popolo intero, se si ricorda il ricordo di Carlo Levi scrittore e suicida, si comprende la violenza di Israele oggi, anche al di là di geopolitiche che la sostengono; la si comprende, non la si giustifica. E questo è altrettanto terribile.
L’amore e il femminismo: Desiderio «Là conobbi un desiderio senza pari / e quel tempo era il giorno settimo del sabato / e tutti i rami degli alberi crescevano alti e forti. / La luce fluiva dappertutto, come un fiume, impetuosa, / e la ruota dell’occhio anelava alla ruota del sole. / Allora conobbi un desiderio senza pari. …»; Bambola meccanica «Questa notte sono stata una bambola meccanica / mi sono voltata a destra e a sinistra, in tutte le direzioni / e sono caduta faccia a terra e mi sono rotta in mille pezzi / e hanno provato a rimettermi insieme con mano esperta. // E poi sono tornata ad essere una bambola riparata / e tutto il mio agire era misurato e obbediente, / ma ero ormai una bambola di seconda scelta, / come un ramo ferito che ancora si aggrappa a un viticcio. …»; I rospacchi «… Come una ninfea gialla incantevole / molti non raggiungeranno un’altra vasca. / I rospacchi sono ciechi davanti / all’angoscia terribile del nostro cuore.»; Secondo natura «Un uomo esce al mattino o a mezzogiorno / o alla sera / da casa sua e scompare. / Che cosa significa “scompare”? / Del resto chi non è qui si trova là. / Eppure scompare, letteralmente scompare. / Il significato è abbandona, il significato è abbandonato / il significato è andato al diavolo. …»; Un tamburo nelle tempie « Stavo vicino alla porta e pensavo / chissà se adesso è in casa / … / Ero emozionata e felice / che mi avesse fatto entrare. / … / E mi eccitai a tal punto / per aver avuto io stessa il coraggio / di toccare la maniglia, …»; Aleggiare a bassa quota «… La bambina gli era molto vicina, / nessun altro attorno a loro. / E se anche avesse provato a nascondersi o a gridare: / non ci sono nascondigli sulle montagne. / … / il suo palato è secco come argilla, / mentre una mano dura le carezza i capelli, la stringe / senza un briciolo di pietà.». In questi passaggi l’oscillazione costante tra il desiderio, il quotidiano, la violenza, dove il maschile resta sempre mediocre o distratto, impietoso o violento, e la fuga non può che essere al di fuori della realtà in un inconscio esotico tra immagini lontane e le parole delle sue sacre scritture.
Solo per il figlio Ido, tanto desiderato, l’amore non ha confini: Ossigeno «Un geco sul muro di casa tua, Ido, / voglio essere. / … / Tutte cose che ti accompagnano ogni giorno / ti vedono e sono assorbite / nell’area del tuo campo visivo. / … / Non stiamo parlando di amore, Ido. / Voglio essere l’intonaco dei muri / l’architrave di una finestra o il cassetto dei calzini / in una stanza che assorbe il processo / del tuo metabolismo / otto ore ogni notte.». Ed è solo all’amore materno che si concede una possibile verità, che va anche oltre l’amore mentale per restare cordone mai spezzato di latte e di sangue. Ed anche all’amore per la verità gli si deve attenzione, e più di una poesia è dedicata al poeta rivale, sofferente e anticonformista, Yona Wallach, morta prematuramente: Finalmente parlo io «Yona, shalom, / ora parlo io e tu non puoi interrompermi. / … / e hanno detto che sei santa, e sono impalliditi / e hanno detto che sei impura e hanno sospirato, / hanno detto Santo Santo, puttana puttana / e innumerevoli denti aguzzi hanno dilaniato il cadavere / e questo era un segno che questa volta eri morta e non viva, / … / e dicono di te cose prive di spontaneità / i numerosi eredi che ti sei lasciata alle spalle, / hai dato loro l’autorizzazione / e non hai dato loro la responsabilità. …». E questi ultimi due versi, precisi, ad indicare chi si fa carico dei propri comportamenti per poter scrivere in un certo modo, spezzando regole e gabbie preesistenti per diventare indicatore di nuove libertà, usate ed abusate da epigoni vuoti di senso e di verità.
Resta la guerra, per concludere, con i suoi eserciti, i suoi dolori, i suoi misfatti, le tragedie indescrivibili che dalla “grande” storia si riversano sulle “piccole” storie degli incolpevoli: Cosa succede «… Che strano, / lo attende un funerale di stato. / Una medaglia al valore. / La stretta di mano del Capo di Stato Maggiore. / E oggi ulula il vento sulle alture del Golan / come un idrofobo. / Che cosa ci succede? …»; Quest’incubo «… E non c’è sulla mappa la Terra d’Israele / forse non esisteva ancora la Terra d’Israele. / Herzl trama intrighi di nascosto / ma Weizmann, come sempre, è più astuto. / E di nuovo si svolge il Congresso Sionista / e un ragazzino guida tutti quanti. / Da dove viene sempre quest’incubo? // Quello che era erba non è più / e anche Gerusalemme ha deviato dai suoi confini. / … / E sopra Ein Karem, nella luce / potrò piangere Shammai Cohen / che splendeva come la luce di Gerusalemme / e nello spazio di un giorno è stato sepolto. / E la terra devierà dalla sua intelaiatura, / e un ragazzino guiderà tutti quanti.»; Non si uccide un bimbo due volte «Nelle acque di scarico di Sabra e Chatila / là trasferiste una gran quantità di persone / degne di rispetto / dal regno dei vivi a quello dei morti. // Notte dopo notte. / Prima spararono / poi impiccarono / infine sgozzarono con i coltelli. / … / E i bambini già giacevano nelle acque putride / le bocche spalancate, / in pace. / Nessuno potrà fare loro del male. / Non si uccide un bimbo due volte. / … / I nostri dolci soldati / non chiesero nulla per sé, / com’era intenso il loro desiderio / di tornare a casa sani e salvi.». La capacità di guardare sempre dai due lati, la capacità di usare una “semplice” parola pace, in pace, come un unico verso, quello dell’indicibile, del silenzio, della sparizione, della morte. La poesia, quella importante è capace anche di questo. Storia dell’arabo che morì in un incendio «… Il fuoco lo afferrò all’istante / per questo non esistono metafore / sbucciò i suoi vestiti / afferrò la sua carne, / i nervi della pelle furono colpiti per primi, / i capelli divorati dal fuoco, / … / il divampare del fuoco nella sua carne / silenziò il suo senso del futuro / e le memorie della sua famiglia. / … / Desiderava soltanto smettere di bruciare / ma il suo corpo nutriva l’incendio. …»; Giovenca decapitata «Fece un altro passo, / fece qualche altro passo. / Gli caddero gli occhiali / gli cadde la kippà. / Fece un altro passo / grondando sangue, / trascinando le gambe / dopo dieci passi / non era più ebreo / né arabo: / astratto. …». Ancora una parola che si fa verso, solo, isolato, metafisico: astratto, come la pace di prima.
Tutto s’intreccia: la insopportabilità angosciosa di una vita sempre imperfetta, la rivolta contro il maschilismo maschista e la guerra sempre ingiusta dove non c’è da dividere banalmente a metà colpe e ragioni, ma ingiustizie più grandi e meno grandi, dolori e sofferenze inflitte e ricevute in maggiore o minore quantità.
Muore a sessantanove anni. Suicida perché affetta da sindrome bipolare con crisi depressive? O sarà stata questa dichiarazione frettolosa, una diminutio per chi non aveva celebrato uno stato come i poeti maschi che l’avevano preceduta, criticando il suo potere persino sul piano umano? O fu l’insufficienza cardiocircolatoria di cui era affetta? Il figlio Ido la difende e i medici propendono per il male fisico e non mentale. La politica bassa è capace anche di questo. La sua sporcizia endogena vuole seppellire sporcando chi non la sostiene. Come se una sofferenza mentale fosse un’ingiuria, una roba da accantonare e rimuovere, e senza alcuna attenzione alla profondità ed alla oscurità lucente della psiche, della poesia, dell’arte, del cielo nel suo abisso di stelle.
«Cos’avrò fatto? / Io per anni non ho fatto nulla. / Ho soltanto guardato dalla finestra. …»; «… Adesso scrivo, mi fermo, / capirai, / molti fogli di carta mi si sono piantati nella gola. / Io, se così si può dire, non sono più io. / Sono metà di me, diminuisco in fretta. …».
Mola di Bari agosto 2024



